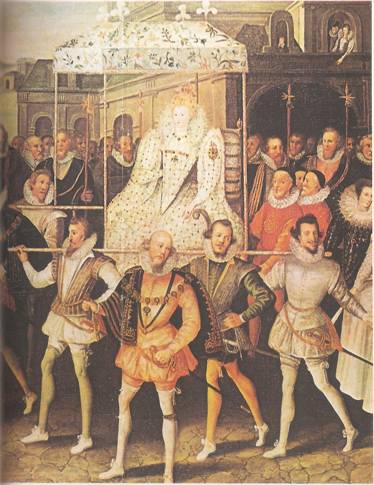
L�INGHILTERRA
DAI TUDOR
AGLI STUART �
MICHELE E. PUGLIA
PARTE SECONDA
SOMMARIO: ELISABETTA RICONOSCIUTA REGINA DAL
PARLAMENTO;� NELLA VITA DI ELISABETTA APPARE THOMAS SEYMUR;
ELISABETTA COINVOLTA NEL COMPLOTTO DEI PROTESTANTI CONTRO LA REGINA MARIA;
ELISABETTA AD HATFIELD DEDITA AGLI STUDI LE PRIME PROPOSTE
DI MATRIMONIO; RIFIUTO DEL PAPA DI
RICONOSCERE ELISABETTA REGINA E LA PROPOSTA DI
MATRIMONIO DI FILIPPO II; PRIMI
SUCCESSI POLITICI ELISABETTA RISOLVE I PROBLEMI CON FRANCIA E SCOZIA; SFARZO E
SPESE DI ELISABETTA LE SUE RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI MATRIMONIO VISITA A CAMBRIDGE E OXFORD; I PIRATI PONGONO
LE BASI DELLE COLONIE E DELL�IMPERO; IL COMPLOTTO DI
BABINGTON PER ASSASSINARE ELISABETTA IL PROCESSO E LA CONDANNA DI MARIA STUARDA; L�ULTIMA FASTOSA AMBASCIATA DI CHARLES BIRON RICEVUTA DA
ELISABETTA E LA SUA ULTIMA SFURIATA; LA VITA LICENZIOSA DI
ELISABETTA DESCRITTA DA MARIA STUARDA E LA CRISI COLLERICA AVUTA DOPO LA SUA
ESECUZIONE; �MARIA STUARDA LA VITA
PARALLELA CON ELISABETTA SEGNATA DAL SUO TRAGICO DESTINO; LE PRIME ESPERIENZE
NEGATIVE DI MARIA CON KNOX
IL TRIBUNO RIFORMATORE DI SCOZIA; ALLA CORTE SCOZZESE
GIUNGE IL BEL DARNLEY MALIZIOSO OMAGGIO DI
ELISABETTA; DAVIDE RICCIO ASSASSINATO IN PRESENZA DELLA REGINA INCINTA;
BOTHWELL LA NUOVA PASSIONE DI MARIA E L�ASSASSINIO DI DARNLEY; LE DISASTROSE CONSEGUENZE DEL MATRIMONIO DI MARIA CON BOTHWELL; GIACOMO I DI
SCOZIA FINALMENTE RE D�INGHILTERRA E LA CONGIURA DELLE POLVERI; �LA FINE DELLA SFORTUNATA DINASTIA DEGLI
STUART.
�
ELISABETTA
RICONOSCIUTA
REGINA
�DAL PARLAMENTO
�
|
A |
lla
morte della regina Maria (1558) Elisabetta si trovava lontana dalla Corte, nella
reggia di campagna a Hartfield, in stato di quasi
prigionia, tra mille occhi che la spiavano, sospettata del suo coinvolgimento
nella congiura ordita contro Maria dai protestanti, in seguito al trattato (1554),
per il suo matrimonio con Filippo II di Spagna. osteggiato,
come vedremo, dai protestanti. ������
Elisabetta
aveva venticinque anni e diveniva regina per meriti propri, piuttosto che per
le leggi del regno, passati tra varie vicissitudini ordite contro di lei fino
all�assassinio e con una solida preparazione di studi e di esperienze, che
l�avevano formata nel carattere e nella personalit�. �
Esile
nella persona e non bella nelle fattezze del viso per il naso adunco,
Elisabetta aveva occhi penetranti che sprigionavano un magnetismo che colpiva
la singola persona o le intere folle plaudenti: insomma aveva qualcosa di pi�
della bellezza fisica, il fascino.
Era
la personificazione dell�intelligenza a tutto campo. Il suo pensiero penetrava
come una lama, concetti, idee e argomenti che, per quanto potessero essere
ostici, per lei, non serbavano angoli oscuri.
Aveva spiccato il senso della teatralit�, e
tutto per lei costituiva un gioco, nell�amore come nell�arte di regnare e ancor
pi�, nella sottile arte della diplomazia ed era testarda ed eternamente
indecisa,
Quanto
agli studi aveva avuto una preparazione considerevole nelle lingue e nelle
scienze; a dodici anni conosceva la geografia, la cosmologia, le matematiche, �l�architettura, la pittura, l�aritmetica, la
storia, la meccanica, con grande ammirazione degli insegnanti, meravigliati dal
fatto che una bambina potesse apprendere tante cose.
Nelle lingue aveva facilit� di apprendimento e
aveva appreso il latino da Bingast, il suo precettore,
apprendendolo cos� bene che i personaggi eruditi che la visitavano, avevano
piacere di parlarle in questa lingua. Alla stessa maniera aveva appreso
l�italiano, il francese lo spagnolo e il fiammingo, che parlava e scriveva in
ciascuna di esse con naturalezza; amava invece poco la poesia che considerava
come un divertimento inutile, preferendo la storia e la� politica che leggeva in tutte le lingue,
dedicandovi tre ore al giorno e le altre ore diversamente impegnate (tutti i
figli di Enrico erano dotati di intelletto, Maria, era stato detto, ancor pi�
di Elisabetta ed Edoardo discettava fluentemente in latino).
Quanto
alle esperienze di vita che le avevano formato il carattere, aveva dovuto
subire gli alti e bassi del padre Enrico VIII che, nel
diseredare� Maria (1535), dichiarandola
incapace di succedergli, disponeva la legittimit� di �Elisabetta come erede della Corona. Ma, quando
dopo l�esecuzione di Anna Bolena (v. P. I), Enrico VIII aveva sposato Jane Seymur,
faceva dichiarare dal Parlamento (1536) la esclusione dalla successione di
ambedue le principesse, disponendo che sarebbero succeduti i soli figli della
(nuova) regina, secondo il loro rango. La esclusione delle due principesse era
ulteriormente confermata con un altro atto del Parlamento dello stesso anno.
Dopo
il matrimonio di Enrico con Anna di Cleves (1540), per
il quale il re si era rifiutato di consumare il matrimonio (v. P.I), Anna aveva accettato il divorzio (pronunziato dalla
Chiesa e dal Parlamento), e si era trovata cos� bene in Inghilterra da aver deciso
di non tornare in Germania. Reintegrata nel titolo di principessa, Enrico le
aveva accordato per dimora una sua casa di campagna, con diecimila scudi di
rendita, oltre alle spese ordinarie per la servit� necessaria per servirla
onorevolmente.
Ma,
fatto singolare, Anna aveva conosciuto Elisabetta (che aveva sette anni) e,
dopo averla vista due sole volte, l�aveva trovata cos� piacevole e piena di
spirito, da aver chiesto ad Enrico di volerla avere con s�; Enrico le aveva risposto
che avrebbe potuto vederla ogni tanto, ma Anna voleva che andasse ad abitare
con lei e questo permesso non le era rifiutato.
Intanto Enrico sposava Catterina
Howard, cugina di Anna Bolena, che nutriva delle tenerezze
nei confronti di Elisabetta e Caterina, per il giorno delle nozze, aveva voluto
avere a tavola Elisabetta seduta di fronte a lei; e il giorno della sua incoronazione
le aveva fatto riservare un posto speciale durante la cerimonia. Anche la nuova
regina aveva espresso il desiderio di avere Elisabetta con s�, ma la piccola Elisabetta
aveva fatto pregare il padre di lasciarla presso la principessa di Cleves (Leti, Vie d�Elizabeth
d�Angleterre) .
Il rapporto del re con la nuova regina non era
durato neanche tanto, in quanto Cateria Howard (v. P.I), saliva sul patibolo nella piazza della Torre (1542). Il
re, che non riusciva a star solo, aveva �puntato i suoi occhi su Caterina Parr, vedova del barone di Latimer,
sorella di Guglielmo Parr, conte di Essex.
La Parr, vista la
fine che avevano fatto le sue mogli, aveva detto al re che preferiva essere la
sua concubina, piuttosto che la moglie; �ma il re la spos� ugualmente e la fece
incoronare.
Caterina Parr, prima
di sposare Enrico, aveva avuto modo di conoscere Elisabetta di cui ammirava lo
spirito e le maniere e dopo essere salita al trono (1543) chiedeva al re di far
venire Elisabetta (che aveva dieci anni) a Withehall;
ma Anna di Cleves se ne dispiacque e il re decise che
la bambina potesse andare a passare delle giornate settimanali da lei e a Witehall le fu riservato un appartamento.
Agli inizi del 1544, Enrico faceva rivedere dal
Parlamento le disposizioni sulla�
successione, disponendo che nel caso il principe Edoardo (nato da Jane Seymur 1537), fosse morto senza figli legittimi, o che egli
stesso non ne avesse avuti, sarebbe stata la principessa Maria a prendere la
corona; e se questa principessa fosse morta senza figli o per violazione delle
leggi del regno .... la corona sarebbe stata assegnata alla principessa
Elisabetta e suoi eredi; e in caso di indegnit� la corona sarebbe andata a chi
il re avrebbe nominato nel suo testamento. Cos� le due principesse erano state
reintegrate nel loro ruolo di eredi, con l�assegnazione di ufficiali e
domestici, appoggiate, Maria dai cattolici ed Elisabetta dai riformati (1545). �
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�
��
NELLA VITA
DI ELISABETTA
APPARE
THOMAS SEYMUR
����������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������
|
L |
e cose erano a questo punto quando (1547) morto
Enrico VIII saliva al trono Edoardo VI, di dieci anni, mentre a Corte appariva il giovane
ammiraglio Thomas Seymour, fratello del reggente Edward, conte di Hertford (fratelli di Jane e zii del piccolo re), il quale autonomamente
si concedeva la nomina di duca e tutore ed esecutore testamentario del re
Edoardo VI. �
Thomas. giovane dal fisico prestante e dal
carattere brillante, con il fratello che come tutore sostituiva il re e lui
ammiraglio della flotta inglese, pieno di ambizione, aveva pensato a un
matrimonio prestigioso che potesse portarlo sul trono.
Escludendo Maria che non era di bell�aspetto ed
era di qualche anno pi� vecchia di lui, aveva rivolto le sue attenzioni verso
Elisabetta, che non aveva ancora compiuti quattordici anni, ma aveva un giudizio
pi� solido di una donna di maggiore et�.
Era appena morto il re e Thomas senza
rispettare il periodo di lutto, le scriveva una lettera appassionata con cui
manifestava il suo desiderio di sposarla; Elisabetta non ne fu sorpresa,
sapendo che in Inghilterra avvenivano matrimoni tra semplici gentiluomini e le
figlie e sorelle dei loro re. Ma, attempata com�era, gli rispose di non avere
ancora n� l�et�, n� l�inclinazione per pensare al matrimonio, aggiungendo che
non avrebbe mai creduto di dover parlare di questo argomento, quando doveva
pensare a piangere la morte del padre. Aggiungendo: �Prender� questa decisione quando
sar� divenuta donna, nella giusta et� da marito; permettete di dirvi
francamente che non vi � nessun�altra persona che abbia tanta stima per i
vostri meriti di me ...e voglio avere il piacere di �conservare l�attuale nostro rapporto, senza
entrare nella stretta confidenza del matrimonio�.
Seymur, dopo questo elegante rifiuto, non si perse
d�anime e si mise a corteggiare la regina dotaria Caterina,
che aveva tre anni pi� di lui, la quale, alla proposta dell�ammiraglio di
sposarla, �aveva risposto �con favore alla richiesta, dicendo che �aveva passato la sua giovinezza con un
marito vecchio e malato (passando le sue giornate tenendo in grembo la
gamba malata di Enrico VIII ! ndr.) e per lei non� sarebbe stato spiacevole passare la sua vita
con un altro, giovane e vigoroso�. Dopo aver sottoscritto gli accordi
matrimoniali (trentaquattro giorni dopo la morte del re), qualche mese dopo
celebrarono le loro nozze.
L�ammiraglio, con questo matrimonio affrettato,
aveva suscitato dei malumori ed era stato accusato di non aver rispettato il periodo
obbligatorio di vedovanza della sposa,
in quanto nel caso fosse rimasta incinta, non si sarebbe saputo se il figlio
fosse suo o del defunto re. Elisabetta, dal suo canto, ne era rimasta
dispiaciuta per due mtotivi, il primo perch� Seymur aveva offeso la memoria del re sposandosi quando,
per cos� dire, il re non era stato ancora interrato; il secondo, per il �comportamento tenuto da Caterina l�indomani
della morte del re, in quanto, egli, recatosi a porgere le condoglianze, invece
di riceverlo nella sala delle visite, lo aveva ricevuto nel suo gabinetto privato,
trattenendosi con lui lungamente e comportandosi
con lui in maniera impudica.
La principessa Maria, ancora pi� sensibile, ne
era rimasta pi� dispiaciuta in quanto, come erede presuntiva alla corona, si
sentiva pi� obbligata a deplorare il matrimonio che disonorava la memoria del
padre.
Caterina abitava a Chelsea dove Thomas era
andato ad abitare e qui si era trasferita (1547-48) anche
Elisabetta con la inseparabile Kate, gli�
insegnanti� e le giovani dame di
compagnia.
Abitando
nello stesso palazzo, Thomas che aveva trentacinque anni (*)
aveva preso l�abitudine al mattino (indossando
la sola camicia da notte), di recarsi, da Elisabetta, prima che si fosse
vestita (non indossando alcun indumento, come si usava all�epoca), per augurarle
il buongiorno; ... ma non si fermava qui, perch�, scherzoso e licenzioso,
giocava con la fanciulla dandole dei colpetti sulle spalle e sul sedere oppure,
aperte le tende, saltava sul letto e lei strillava e cercava
di nascondersi sotto le coperte. Alla fine,
quei giochi che creavano
intimit� e davano un certo piacere, erano divenuti tali che la fanciulla, tra
un gioco e l�altro e tra una sculacciata e l�altra, perdeva la sua� verginit�.
Elisabetta
pare che in quel periodo, fosse rimasta incinta e avrebbe abortito in
circostanze misteriose: da allora era rimasta sterile, ci� che le dar� in
seguito la possibilit� di vantare la sua verginit�,
certamente non intesa come lei� voleva quando
parlava di �vergine regina�; (v. in
Art. Rinascimento magico alla corte di
Elisabetta); vale a dire quella pubblica �idealizzata�. Invece, quella derivante dalla sua sterilit�, a lei, durante
il suo lungo regno, avrebbe dato la possibilit� di avere molteplici amori (i
maligni la ritenevano �naturalmente
portata al vizio, ereditato dalla
madre�!), da aver potuto avere con i propri amanti rapporti liberi e soddisfare
tutte le voglie di un libero amore (come le rinfaccer� Maria Stuarda nella
lettera di fiele che le aveva scritto durante la sua prigionia, come si vedr�
pi� avanti).
�Caterina
Parr in quel periodo (1548) era rimasta incinta e metteva
alla luce una bambina; durante il parto non stava bene e vaneggiava e inveiva
contro il marito che cercava di consolarla; ma lei lo accusava di averle
inflitto moltissime dolorose umiliazioni e il 5 settembre, tra i vaneggiamenti,
spirava;, che, libero, mirava a sposare Elisabetta; erno
sorti dei sospetti di avvelenamento da parte del marito, avvalorato dalla
circostanza che Thomas le aveva fatto firmare il testamento sul letto di morte e
lei gli aveva lasciato il grosso delle sue sostanze: ma i sospetti erano
rimasti tali.
Thomas sentendosi libero di dar sfogo alla sua
ambizione, nella sua incoscienza, aveva deciso di rapire Edoardo dal quale era
riuscito a conquistarsi le simpatie (dandogli di nascosto del denaro), per
fargli fare ci� che lui voleva; vale a dire sposare Elisabetta e privare il
fratello dell�incarico di Protettore, in modo da assumere la direzione degli
affari del regno.
Egli disponeva di un�armata di diecimila
uomini� con molti nobili che lo
appoggiavano; la sua giustificazione era quella di difendere la libert� del re
e della Nazione. Una notte (agli inizi del 1549) introdottosi nel palazzo reale
si era diretto verso la camera del re, eludendo la sorveglianza, ma giunto
davanti alla porta della stanza dove Edoardo dormiva, il cane che faceva la
guardia, si mise ad abbaiare dando l�allarme: Thomas inutilmente lo uccideva,
sparandogli un colpo con la sua pistola, ma nel frattempo arrivavano le guardie
e lo arrestavano per ordine del fratello Protettore e fu condotto alla Torre.
Fu nominata la commissione giudicante che per
la complessit� del processo fece intervenire il Parlamento e istruita la causa,
dopo un discorso del Protettore in cui sottolineava di essere estremamente
dispiaciuto della disgrazia in cui era precipitato il fratello e che lui aveva
fatto ogni sforzo per distoglierlo; che la persona del suo principe doveva
essergli pi� cara del proprio sangue e che lui preferiva gli interessi del suo
re a quelli di suo fratello e dei propri figli, era emessa (27 Gennaio 1550) la
sentenza di condanna e l�esecuzione ebbe luogo nella piazza della Torre. �
Questa fu la fine di Thomas Seymur,
Ammiraglio d�Inghilterra, �i cui disegni
erano stati vasti e lo spirito grande ed elevato, l�umore violento e l�ambizione
smisurata�. Quando Elisabetta apprese la notizia disse �che era morto un uomo di grandissimo spirito
ma di poco giudizio... e non lasci� trasparire il dispiacere della disgrazia�.
Il Lord Protettore,
duca di Sommerset, riteneva che i guai che il
fratello gli aveva procurato fossero finiti; ma il Parlamento era irritato nel
vedere che gli affari con la Scozia, con la Francia e quelli del regno, pieno
di disordini e rivolte, andavano male e imputava tutto ci� alla loro pessima
conduzione da parte del lord Protettore.
Il risentimento era tale che gli fu mandato il
conte di Sussex per arrestarlo e condurlo alla Torre,
dove fu processato e, abbandonato dai parenti e dagli �amici, in particolare, dai pi� favoriti, fu condannato
a morte; la sua esecuzione ebbe luogo sulla stesso patibolo dove era avvenuta
l�esecuzione del fratello.
Le sue grandi qualit� avrebbero mer�tato un migliore e pi� glorioso destino, ma nessuno
come lui era stato tanto detestato dal popolo; in particolare i cattolici
(aveva dato a Edoardo precettori nemici della Chiesa di Roma), lo ritenevano un
loro grande nemico e si auguravano che senza di lui si sarebbero risollevati e ne
gioirono: Ma dovettero attendere ancora tre anni, fino a quando non fosse morto
Edoardo VI e non fosse salita al trono Maria, detta la
Cattolica.
Prima che Maria salisse al trono, si era
presentato uno strano intermezzo dovuto alla circostanza che per la riforma preparata da Edoardo nel suo
testamento, aveva escluso le due sorelle, Maria perch� cattolica ed Elisabetta perch�
aveva dato l�impressione di essere papista per i buoni rapporti che (all�epoca)
la univano a Maria, e perch� non essendosi chiaramente dichiarata per i protestanti,
si barcamenava tra gli uni e gli altri!
Chi aveva manovrato per questa esclusione nel
testamento era stato John Dudley, duca di Northumberland,
il pi� grande e potente signore del reame, che aveva maritato il figlio Guilford con Jean Grey, figlia del
duca di Suffolk e pronipote di Enrico VIII.
Alla morte di Edoardo, Northumberland,
adunato il governo della citt� a Greenwich, sulla
base del testamento, faceva eleggere regina, Jean Grey,
una ragazza normale, senza aspirazioni e contro la sua stessa volont�. Mentre �Elisabetta trovava il suo rifugio mettendosi a
letto, lamentando una forte colica, Maria fu portata al castello di Framlingham a ottanta miglia da Londra, nella provincia di Suffolk, dove Northumberland era odiato.
Qui fu riconosciuta regina e furono mandati
corrieri a Londra a richiedere ai magistrati e ufficiali il riconoscimento
ufficiale; riconosciuta dalle province di Suffolk e
Norfolk, da Londra Northumberland, non potendo
sostenere con le armi il partito di Jean, l�abbandon�, andando a gettarsi ai
piedi di Maria, oramai riconosciuta da tutto il regno. Northumberland
con i suoi figli fu portato alla Torre; Jean Gray,
regina per nove giorni, dopo una prigionia di due anni, perdeva la vita sul
patibolo, pi� come protestante, che per l�usurpazione del titolo di
regina.�
*)
Il personaggio era stato ben reso da Stewart Granger� nella sua smagliante e istrionica
interpretazione, che aveva saputo sfoggiare in tanti films
storici; in questo film (La vergine
regina del 1952) era in coppia con�
Jean Simmons nella parte di Elisabetta.�
�
ELISABETTA
�COINVOLTA
NEL COMPLOTTO
DEI PROTESTSANTI
CONTRO �
LA REGINA MARIA
�
|
E |
ra usanza dei re d�Inghilterra, appena eletti,
andare a trascorrere dieci giorni� alla
Torre decorsi i quali, con una grande cavalcata si recavano a Westminster per
essere incoronati. �Maria aveva seguito
questa usanza ed era stata incoronata a Westminster (1553) dall�arcivescovo Cramer, in una chiesa piena di cattolici; Elisabetta in
questa occasione non aveva avuto il trattamento riservato a una sorella della
regina, perch� alla cerimonia non era stata invitata.��
Appena incoronata, il primo atto compiuto da
Maria, era stata la richiesta al �Parlamento
del riconoscimento del matrimonio tra la madre Caterina d�Aragona e il padre
Enrico VIII, con la dichiarazione della nullit� delle
nozze di Enrico con Anna Bolena.
Sebbene a molti parlamentari fosse dispiaciuto
vedere Elisabetta non pi� principessa ed esclusa dalla eredit� della corona e
ancor pi� considerata figlia bastarda, l�atto fu approvato all�unanimit� e applauudito, per dimostrare, ciascuno dei votanti, il
proprio zelo verso la regina.
La sorte di Elisabetta ora nella Corte e nel
regno era di essere stata privata delle prerogative riservate ai figli dei re e
avere il trattamento riservata ai figli naturali; le vennero infatti, tolti privilegi� e pensioni che le aveva concessi il padre
Enrico e �mantenuti anche dal fratello
Edoardo VI.
Maria inoltre dispose che andasse ad abitare a
venti miglia da Londra e non le fu concesso neanche di vedere la regina, nei
confronti della quale aveva mostrato affetto e zelo per la sua primogenitura;
Elisabetta per�, le scrisse una umilissima lettera, con richieste che non
furono concesse, all�infuori del mantenimento della servit� ordinaria di dodici
persone.
Maria nutriva nei suoi confronti una certa avversione,
per tre ordini di motivi: �per prima,
l�offesa che Anna Bolena aveva arrecato alla madre,
sposando Enrico (che non poteva essere addossata ad Elisabetta); il secondo era
di carattere religioso, in quanto Maria fanaticamente era cattolica mentre
Elisabetta pur essendo indifferente, propendeva per i riformati; il terzo
motivo aveva un nome: Edoardo di Courtenay, conte di
Devonshire, ultimo discendente dei Plantageniti, di bel
garbo e ben fatto nella persona, amato da Maria gi� prima di diventare regina. �
Maria lo aveva trovato alla Torre (messo agli
arresti da Edoardo), quando era andata a passarvi i dieci giorni di rito e lo
aveva liberato concedendogli molti onori,�
e ritenendo che sarebbe stato anche un ottimo monarca, aveva pensato di
sposarlo. Con Courtenay correvano anche rapporti di
parentela ed era pi� giovane di lei di sei anni, non solo, ma �Courtenay non
ricambiava le sue attenzioni e nutriva nei suoi confronti una certa ripugnanza,
subito notata dalla acutezza di cui Maria era dotata. Sfortuna volle che Courtenay fosse innamorato proprio di chi in questo caso
non avesse dovuto: di Elisabetta, sebbene le loro inclinazioni religiose
fossero diverse; tra di loro vi era gi� una corrispondenza epistolare, che
Maria divenuta gelosa, faceva intercettare. �
Nel frattempo a Maria giungevano le proposte
matrimoniali degli spagnoli per Filippo, che si trovava nelle Fiandre e ai
primi di gennaio (1554) giungeva l�ambasceria di Carlo V, con il conte fiammingo
Lamoral di Egmont (1522-1568),
che proponeva il matrimonio del figlio Filippo, al quale gli inglesi
protestanti si mostrarono contrari; ma il consiglio reale, con maggioranza
cattolica, dava il voto favorevole.
Era sottoscritto un trattato che regolava tutti
gli aspetti successori del matrimonio, ma i riformati inglesi non appena
seppero della sottoscrizione, sostenendo che non intendevano sottomettersi alla
tirannia spagnola e al giogo della crudele Inquisizione, deliberarono di ricorrere
alle armi.
I principali cospiratori erano il duca di Suffolk, i cavalieri Wiatt e Peter
Carrew, ma questa cospirazione sorta prima del
matrimonio di Maria, non aveva avuto nessun seguito e finiva con l�arresto di
tanti innocenti semplicemente sospettati.
Dal momento della pronunzia della validit� del
matrimonio della madre, Maria cercava tutte le occasioni per mortificare
Elisabetta e per la gelosia del suo rapporto con Courtenay,
ora la sospettava di aver partecipato al complotto �e aveva disposto che Elisabetta andasse ad
abitare a Ashriedge, distante tre giornate da Londra;
mentre Courtenay che esercitava delle cariche, era
stato trattenuto a Corte.
In seguito all�interrogatorio di Wiatt e Rochester, costoro avevano accusato Elisabetta e Courtenay �col
disegno di scacciare Maria dal trono e mettervi Elisabetta con la quale erano
stati presi accordi di matrimonio�; ma Rochester quando era stato condotto
al patibolo, tra le lacrime, aveva dichiarato che i due erano innocenti; ma non
si tenne conto di queste dichiarazioni e fu dato ordine di andare a prelevare
Elisabetta e portarla a Withehall per essere
giudicata; Courtenay che nonostante i suoi pregi non
era un eroe, aveva confessato e si era rimesso alla clemenza della regina.
Elisabetta che conosceva le debolezze di Courtenay, nelle sue risposte, persiteva
nelle negative, dicendo �di non ritenere
il conte� Courtenay
capace� di avere avuto il pensiero di far
minima cosa contro gli interessi dell regina e molto
meno di confessare una colpa che non aveva commesso�.
Lo
stesso giorno (1554) la regina aveva dato ordine di condurla alla Torre, fino a
quando non si fosse scoperta la verit�; Elisabetta levava le sue proteste
contro le guardie dicendo che �non
riteneva possibile che la regina, clemente com�era, avesse dato un simile
ordine che certamente era di qualche suo ministro; n� i giudici avevano prove
sulle calunniose accuse contro di lei� ; ma fu portata ugualmente alla
Torre trattata con rigore dal luogotenente, ossia sotto-governatore, cav. Gage. senza possibilit� di poter uscire dalle stanze che le
erano state assegnate.
Elisabetta
subiva questo trattamento per diciassette giorni fino a quando con l�intervento
di milord Chandois,
Governatore della Torre, le fu assegnato l�appartamento dei re (quando andavano
a passare i dieci giorni alla Torre) e di passeggiare per i corridoi e terrazze di piombo, ma accompagnata
dal Contestabile o dal Luogotenente, a condizione che le finestre e le stanze
dove passasse,� fossero chiuse; poi,
sempre con l�intervento di Chandois, ottenne di
passeggiare nel giardino a condizione che le finestre che vi affacciavano
rimanessero chiuse. Un giorno le si era avvicinato un bambino di quattro anni
per consegnarle un mazzetto di fiori, ma glielo tolsero subito di mano e maltrattarono
il bambino, pensando che potesse nascondere qualche biglietto e il padre fu
scacciato dalla Torre.
Alla
regina e al suo Cancelliere Gardiner (*) non
piacevano le premure del governatore Chandois nei
confronti di Elisabetta, che aveva la libert� di avere corrispondenza
epistolare con Courtenay e fu presa la decisione di toglierla
dalla sorveglianza di Chandois e affidarla a Henry Bedingfield, governatore di Woodstock, dove fu mandata
Elisabetta.
Il
brutale trattamento ricevuto da Elisabetta, le fece pensare che il governatore
avesse ricevuto l�ordine di farle perdere, tra le afflizioni, la vita.
Nel
frattempo Maria aveva sposato Filippo II (v. cit. P.
I), considerato �inumano, barbaro e
crudele, che non risparmiava il sangue neanche delle sole ombre degli eretici; ma
mentre Maria regnava facendo strage dei protestanti, Filippo, in Inghilterra,
si mostrava clemente e compassionevole, fingendo di chiedere grazie, non per
propria inclinazione, ma per guadagnarsi la benevolenza degli inglesi; essi si erano
infatti persuasi della sua benignit� e clemenza, ritenendolo incline a graziare,
piuttosto che a punire con rigore.
Filippo,
nel momento in cui si accorse che la voce della sua clemenza si era sparsa tra
gli inglesi, pens� di comportarsi in modo da guadagnarsi la loro simpatia; venuto
a conoscenza che la gravidanza di Maria fosse una finzione e resosi conto che
Elisabetta era amata dal popolo, chiese alla regina di concedere la libert� alla
sorella ed Elisabetta fu trasferita da Woodsock a Hamptoncourt, rimanendo per� ancora sotto custodia, in
quanto Maria voleva che prima di concederle la libert�,� la sorella confessasse la sua colpa.
�Gli aveva mandato Gardiner,
il quale le riferiva che il re e la regina le concedevano la grazia ma lei
doveva confessare la sua colpa per evitare la formalit� di un processo.
Elisabetta gli rispose senza mezzi termini che lei non aveva nessuna colpa da
confessare. �Quello che posso
assicurarvi, in tutta coscenza � che ho sempre avuto
in orrore il pensiero di offendere chicchesia e tanto
pi� la persona e gli interessi della regina, mia signora e sorella ... e
conoscendomi innocente preferirei perdere piuttosto la vita, che macchiare la
mia innocenza con una confessione indegna del mio onore e della mia innocenza�.
Gardiner cos� mortificato fece il rapporto del
colloquio alla regina che decise di mandarle il cardinal Polo (v. P. I), con
l�idea di farla diventare una buonna cristiana. Il
colloquio tra il cardinale ed Elisabetta era stato lungo, di alto livello ed
interessante: intenzione di Polo era di convertirla.
Elisabetta
se ne usciva con destrezza e il cardinale era giunto alla convinzione che la
testa della principessa fosse nutrita di religione
politica, nel senso che per lei la religione era quella del governo dello
Stato e dal lungo colloquio avuto col cardinale, non era venuto fuori altro che
la sua indifferenza per la religione, senza troppo zelo per quella che
professava e senza alcun odio nei confronti della cattolica, che intimamente
aborriva.
E
a questo modo, alla morte di Maria, Elisabetta si guadagner� le grazie di
ambedue i seguaci, cattolici e protestanti, ciascuno dei quali riteneva che lei
fosse dalla propria parte, lasciando agli uni e agli altri il libero godimento
dei propri sentimenti e delle proprie funzioni e proteggendo sia gli uni che
gli altri, come poi avvenne. Il cardinale tornato dalla regina si era mantenuto
sulle generali e Maria decise di convocarla a Corte con il re che sarebbe stato
nascosto dietro le tende.
Giunse
Elisabetta alla udienza fissata, gettandosi in ginocchio ai piedi di Maria,
grondando di lacrime e dichiarandosi innocente; la regina era stata istruita da
Gardiner di non mostrare tenerezza per le lacrime e
per le giustificazioni e senza farla alzare, la sollecit� a non voler nascondere
la colpa per salvare il suo onore, perch� non voleva essere tacciata di aver
perseguitato una innocente, avendo gi� deciso di perdonarla.
Elisabetta
rispose di aver sofferto con pazienza le afflizioni imposte e per alleviare i
suoi patimenti avrebbe accettato quella sola che Sua Maest� avesse voluto
imporle, perch� potesse avere una migliore opinione di lei ... ed altro
aggiunse; Maria si intener� e facendola alzare la abbracci�, dicendole: giusta
o colpevole vi perdono; e poich� stava avanzando la notte le fece dare delle stanze
a Withehall. Filippo usciva soddisfatto da dietro le
tende (era un suo debole: gli piaceva spiare!); la mattina forse per
conciliarla, le fu mandato Gardiner che le disse di
essere reintegrata nelle pensioni concesse da Edoardo, ma senza alcuna
prerogativa di sangue o di eredit� sulla Corona, con facolt� di poter restare a
Withehall o andare in una delle case regia di
campagna; al momento Elisabetta scrisse subito due lettere, a Maria e a Filippo,
che si era interessato di lei, e fu poi da loro ricevuta in udienza. ��
Maria
l�accolse con affetto .... ma durante la visita si era accorta che Filippo,
colpito dalla freschezza di Elisabetta, ne fosse rimasto affascinato e le aveva
rivolto grandi premure, che le avevano suscitato i morsi della gelosia e
l�avevano portata a pensare di allontanarla dalla Corte.
La
situazione era stata aggravata dalla circostanza che tra la popolazione si era
sparsa la voce che Elisabetta fosse a Londra e si radunava presso la Corte, e
in altri posti erano stati accesi fuochi;�
e quando Elisabetta per tre volte era uscita a cavallo, non si erano
sentite che acclamazioni, che non erano state fatte alla regina. �
Ora
si aggiungeva quest�altro motivo di gelosia a quelli gi� indicati; mentre Gardiner suggeriva alla regina che �la libert� concessa a Elisabetta, minacciava sinistri presagi al regno�.
Era stata la stessa Elisabetta a rendersi conto che non fosse il caso di
rimanere a Withehall e quando chiese alla regina di
licenziarsi, Maria le aveva risposto freddamente �trovo che fate bene� �ed
Elisabetta si ritirava a Hartfield.
�
�
*)
Stefano Gardiner vescovo di Winchester, messo agli
arresti da Edoardo, era stato liberato dalla prigionia da Maria che lo aveva
creato Cancelliere del regno; era stato il maggior persecutore di Elisabetta
per la quale, prima aveva suggerito l�assassinio, poi la sua prigionia.
La
mancanza di uno� spirito critico, che
dovrebbe accompagnare �chi si dedica alla
politica e sia chi si dedica alla religione, porta spesso alle esasperazioni del
fanatismo; e si giunge agli assassinii, come avviene tutt�ora nell�Islam o
avveniva da parte dei cristiani quando combattevano contro quelli che
consideravano i loro avversari, con le sadiche torture o facendone strage.
Mentre ora si � passati agli opposti eccessi della conservazione della vita a
tutti i costi, accanendosi sull�embrione, per quelli che si oppongono agli
aborti o non lasciando libert� di scelta per coloro che vogliono terminare la
loro vita, per porre fine alle sofferenze; e per puro fanatismo vi � chi si
oppone, alla approvazione della legge sulla eutanasia,
sebbene suggerita �da un organo
istituzionale come la Corte Costituzionale.
�
��
ELISABETTA
�A HARTFIELD
DEDITA AGLI STUDI
�LE PRIME
PROPOSTE
DI MATRIMONIO
�
|
E |
lisabetta, a venidue
anni, ad Hatfield, si era dedicata agli studi leggendo
Machiavelli la cui fama si era sparsa per tutta l�Europa e Tacito, e tutti i
testi di politica che le capitavano; rilesse la storia di Roma e i Conmnentari di Giulio
Cesare, la vita dei pontefici, quella degli imperatori, oltre alla storia
d�Inghilterra e di Scozia e tutte i successi delle guerre e delle paci, non
tralasciando le recenti storie di Carlo V, di suo padre Enrico VIII e di Francesco I di Francia.
Nei libri che leggeva faceva annotazioni ai
margini e aveva un libretto in cui usava scrivere osservazioni su ci� che
leggeva, passeggiando nei giardini della villa; e non trascurava di occuparsi
di religione, in particolare di Lutero e Calvino.
Manteneva uno scambio di lettere con Courtenay che, con suo dispiacere, moriva (1556) dopo breve
malattia; poich� era noto il loro reciproco amore, si riteneva che avessero
intenzione di sposarsi e si era sospettato un avvelenamento da parte di Filippo,
che aveva delle mire su di �lei, nel caso
fosse morta la moglie: ma erano solo�
ipotesi.
Filippo intanto diveniva re a seguito della rinuncia
di Carlo V (v. in Art.), succedendo in tutti i regni lasciatigli dal padre (1557);
l�anno seguente si trovava a Bruxelles dove incontrava il duca Filiberto
Emanuele di Savoia, che, scacciato dai francesi dalla Savoia, era divenuto
celebre capitano.
Filippo, per festeggiare il suo avvenimento, si
stava recando dalla moglie a Londra e il duca, al quale in precedenza aveva
proposto il matrimonio con Elisabetta, si era offerto di accompagnarlo,
sperando in un suo matrimonio con Elisabetta. �Questa volta per� �Filippo, pensando alla possibilit� di sposare
lui Elisabetta, gli aveva suggerito che fosse meglio rimanesse al governo delle
Fiandre, avrebbe pensato lui a concludergli le sue nozze con la regina.� ������
Nello stesso tempo, si era sparsa la voce, che
le nozze tra Elisabetta e il duca stessero per concludersi, messa in giro dallo
stesso Filippo, ma solo per evitare che si facessero avanti altri pretendenti
... che si erano ugualmente presentati. ��
Si trattava di Erik di Svezia (1533-1577), figlio di Gustavo I, il quale aveva mandato
un�ambasceria a Londra, col pretesto di congratularsi per la vittoria
conseguita da Filippo sui francesi (Saint Quentin).
L�ambasciatore, dopo essere stato a Corte,
senza affrontare l�argomento di Elisabetta, si era recato (1558) ad Hatfield da Elisabetta; mentre conversavano, quando
l�ambasciatore aveva affrontato l�argomento delle nozze, Elisabetta aveva
mostrato di rimanere attonita: l�ambasciatore, informato sulle possibili nozze
con il duca di Savoia, in maniera maldestra, l�aveva invitata a considerare la
differenza del matrimonio tra il duca e quello con il re; lasciando ancor pi�
meravigliata Elisabetta che, ringraziando l�ambasciatore per la visita, gli
rispondeva che per le nozze non aveva da dare alcuna risposta, per non essere
stata fatta la domanda alla regina, sua signora e sorella. ��
L�ambasciatore messo cos� in imbarazzo si
giustificava dicendo che era venuto in forma privata per saggiare le sue
intenzioni; replicava Elisabetta che con la regina si trovava impegnata in
rapporti di sangue, di ubbidienza e di stima, da non poter accettare alcuna
proposta di matrimonio senza che la regina, sua sorella e signora, le facesse
recapitare un biglietto con cui avesse dato il suo assenso. Con questa risposta
licenziava l�ambasciatore, contento e soddisfatto del bel garbo e delle belle
maniere di Elisabetta, ritenendola degna di nozze per qualsiasi monarca.
La regina, informata, mentre era rimasta
scandalizzata del comportamento dell�ambasciatore e edificata per il
comportamento della sorella, come aveva riferito nel �Consiglio privato, da esserne intenerita. Le mandava quindi, per mezzo del cav. Pope,
una sua lettera, con la quale si congratulava per la condotta avuta con
l�ambasciatore.
Quest�ultimo, tornando dalla regina le riferiva
che il suo re insisteva nella richiesta di matrimonio per Elisabetta; tralasciando
altre numerose richieste, Maria, pur di vedere Elisabetta sposata con un
principe cattolico � senza impegnarsi � �dava
una risposta evasiva, dicendo che prima di dare una risposta, avrebbe dovuto
sentire la sorella, dalla quale mandava nuovamente il cav. Pope per avere
questo suo consenso. �
Elisabetta rispondeva di aver avuto gi� altre
proposte di matrimonio, ma lei aveva intenzione di rimanere vergine e in questo
stato si trovava bene e intendeva continuare a vivere; e avendo preso questa
decisione, non aveva intenzione di sposarsi, con qualsiasi monarca del mondo.
Riferita la risposta alla regina, Maria aveva
pensato a tre motivi che l�avessero determinata; il primo, che non avesse
proprio nessuna voglia di sposarsi; il secondo, che fosse vero il suo
giuramento di rimanere fedele a Courtenay; il terzo
era il peggiore: nel senso che aveva pensato che fosse nei progetti di
Elisabetta che, morta lei, avrebbe sposato Filippo che sarebbe stato il pi�
gran monarca del mondo. Ma su questa idea si dovette ricredere, considerando
che i cattolici la volessero in ogni caso assassinare e ritenne che la sua
decisione fosse proprio quella di non volersi sposare.
Maria
soffriva di� idropisia e le era giunta la
notizia della perdita di Calais e che le truppe inglesi non erano riuscite a
resistere agli assalti francesi, e in questa circostanza moriva anche di
dolore, in quanto, era solita ripetere, se
aprite il mio cuore troverete scritto Calais; era morta senza vedere Filippo,
assente da due anni e mezzo e la causa�
della sua partenza era stata la sua sterilit�, che Filippo aveva giustificato
dicendo di dover prepararsi ad affrontare la guerra.
������������������������������������������������������������������������������������������
�
RIFIUTO DEL PAPA
DI RICONOSCERE
ELISABETTA REGINA
PROPOSTA
DI MATRIMONIO
DI �FILIPPO II
�
�
|
L |
a
elezione �con cui Elisabetta era
proclamata regina era stata immediata sia da parte della Camera Alta sia dalla
Camera Bassa e all�unisono si era sentito �dalla
bocca di tutti: Viva la regina Elisabetta e�
Dio le dia lunga vita e felice governo�.� ��
I
pi� gran signori del regno, tra i quali il duca di Norfolk e il conte di Arundel si erano recati a prenderla ad Hatfield
per portarla a Londra, dove, dopo aver alloggiato nel palazzo di� Arundel, fu portata
alla Torre per trascorrervi i dieci giorni di rito;� qui incontrava Bedingfield,
che le aveva fatto soffrire una dura prigionia e stendendogli la mano per farla
baciare, sorridendo, aveva detto agli astanti: ��Ecco il
mio carceriere�. ���
Durante
la sua permanenza alla Torre, Elisabetta aveva mandato gli ambasciatori ad annunziare
la morte di Maria e la sua successione; a Roma l�ambasciatore Karn riferiva al papa Paolo IV Carafa, il passaggio della corona a Elisabetta; ma il papa,
duro nei sentimenti, disse che �Elisabetta
era una bastarda e non aveva alcun diritto alla corona e non poteva revocare la
bolla di Clemente VII e Paolo III
(che avevano dichiarato la legittimit� del matrimonio di Caterina), suoi predecessori. Che era stata troppo
audace e impertinente per aver assunto il trono senza il suo consenso ...� che se si fosse rimessa al giudizio della
Santa sede, avrebbe potuto avere la sua benedizione ... che non consentiva che
si facesse breccia alla dignit� del Vicario di Cristo, al quale apparteneva la
decisione sui diritti delle Corone
Queste
parole del papa avevano fatto sorgere in Elisabetta la necessit� di propendere
per la religione protestante anzich� per la cattolica.
Elisabetta
fin da quando era entrata nella Torre, aveva scritto (novembre 1558) una lunga
lettera al re Filippo, annunciandogli la morte di Maria e, mostrandogli
particolare affetto, gli aveva riferito�
tutte le traversie subite e il pericolo che aveva corso con i suoi
nemici, che la volevano morta.
Filippo
quando aveva riferito al duca di Savoia di volersi recare a Londra, in effetti
non era pi� partito, ma aveva dato incarico al duca di Fer�a,
di recarsi al suo posto, come ambasciatore, dalla regina Maria. Fer�a era arrivato a Londra quando Maria era morta e le
disposizioni che gli erano state date da Filippo per Maria, erano state immediatamente
cambiate.
Filippo
ricevendo la lettera di Elisabetta, aveva frainteso il suo tenore, ritenendola
ambiziosa al punto che non avrebbe rinunciato a un matrimonio con un grande
monarca; �sicuro che la sua richiesta di
sposarlo sarebbe stata accolta, senza attendere la risposta, aveva mandato a
richiedere la dispensa alla Corte di Roma e aveva dato all�ambasciatore
l�incarico di presentare a Elisabetta la richiesta di matrimonio.
L�ambasciatore,
ottenuta l�udienza, riferiva che �la sua
�accoglienza era stata cos� calorosa, da fargli credere che� il matrimonio sarebbe stato certo; i tratti
del suo viso lasciavano credere al gradimento del suo cuore, e il duca aveva scritto
al re che sperava di vederlo presto sposo della regina a Londra.� Ma le
risposte della regina �erano sempre
spaziose e vaste che appena potevano vedersi con l�occhio e meno comprendersi
con la mente, poich� non solo non faceva conoscere un minimo segno di negativa,
ma mentre dava a credere che fosse per dare il suo consenso, senza dire
mai� nulla di positivo o di affermativo,
restringeva il suo piacere e le sue risposte a parlare dei meriti del re
Filippo e del suo valore in politica, della sua maturit�, prudenza e gran
fortuna� dei suoi popoli di avere un tal
re, del gran vantaggio dell�Europa, di avere una monarca cos� grande, tutto
clemenza e moderazione�.
Insomma,
l�ambasciatore aveva scritto nuovamente al re �Elisabetta era come un�anguilla, quanto pi� si stringeva, tanto pi�
scappava dalla mano�. Alla fine, il Fer�a, pressato
ancora dal re, gli rispose �Sire, questa
regina � simile a una commediante di teatro, che parla molto e non risolve
nulla�.
L�ambasciatore Fer�a
aveva partecipato alla cerimonia della incoronazione e trovandosi con il duca
d�Alba gli aveva detto che il regno di Elisabetta sarebbe stato piuttosto il
regno di una commediante, che di una
regina. Il duca d�Alba gli rispose che era convinto che Elisabetta sarebbe stata la pi� fine politica, perch� i commedianti, aggiunse, guadagnano
con l�adulazione, accarezzando il cuore di tutti, senza impegnare la propria
persona; che dicono una cosa, pensandone un�altra; promettono tutto e non
mantengono niente; convincono con arte e ingannano con grazia. Ecco il vero
ritratto della regina Elisabetta, replic� il duca Fer�a.
La
incoronazione ebbe una incredibile partecipazione di folla, con una cavalcata
di quattrocento cavalli e cento cocchi; la regina era su un piccolo carro
d� trionfo tirato da due soli cavalli,
circondato da quaranta paggi vestiti di scarlatto con fasce bianche ricamate;
seguivano quaranta dame in cocchi scoperti ciascuno con due dame: l�abito della
regina era il primo dei suoi tremiladuecento abiti sfarzosi, che lascer� alla
sua morte; e lo sfarzo era esteso alla corte e richiesto agli ambasciatori, che
quando si presentavano con un seguito ordinario e livree mediocri, soleva dire:
Signor ambasciatore, ci fa un onor secco;
e la Corte era divenuta, come si diceva: Vago
teatro di commedie.
La
cerimonia fu officiata dal vescovo cattolico Overio Ogilthorpe, vescovo di Carlile
che sostituiva il cardinal Polo, da poco deceduto; erano presenti anche due
vescovi protestanti. Elisabetta giur� di mantenere la fede cattolica, confermando
i privilegi della Chiesa; in proposito erano sorte delle polemiche tra i cattolici,
contenti della predisposizione manifestata da Elisabetta e i protestanti i
quali ritenevano che la fede cattolica fosse la vera fede protestante;
Elisabetta liberava quindi tutti i prigionieri protestanti messi nelle carceri
da Maria e anche quelli per debiti, dei quali furono pagati i debiti.
Seguirono
tre giorni di udienze degli ambasciatori, signori e deputati delle citt�� in cui Elisabetta dava prova delle sue doti
di spirito, di zelo, di prudenza e finezza; nessuno si ritirava dal colloquio
senza aver ammirato la sua abilit�, le sue parole accoglienti, la forza delle
sue proposte, la vivacit� e buon senso delle risposte.�������������������������
��� �
PRIMI SUCCESSI POLITICI
ELISABETTA
�RISOLVE I PROBLEMI
CON FRANCIA �E SCOZIA
�
|
I |
n Francia il delfino Francesco figlio di Enrico
II e di Caterina de� Medici, aveva appena sposato
Maria Stuarda, regina di Scozia, alla quale, come erede di Giacomo V i francesi
ritenevano dovesse appartenere la corona d�Inghilterra. Quando seppero che
l�ambasciatore Fer�a stava per concludere il
matrimonio tra Filippo ed Elisabetta e che a Roma si stavano facendo pressioni
per la dispensa, il cardinale di Lorena (zio di Maria), potente (con il
fratello duca) a Corte, sugger� che per tutta la Francia e la Scozia, Maria
fosse proclamata regina d�Inghilterra e d�Irlanda, aggiungendo che Elisabetta
era usurpatrice e bastarda; inoltre il cardinale premeva per una pace tra
Francia e Spagna perch� Filippo sposasse una francese e sostenesse le pretese
di Maria sul trono inglese.
A Londra intanto Elisabetta era incoronata, ma
questa di Maria Stuarda non era la sua principale preoccupazione, che invece era
quella di dover mantenere in Inghilterra la religione cattolica, che lei si era
proposta di eliminare.
In ogni caso, per risolvere� la questione con la Francia, a Londra vi era
un gentiluomo fiorentino, Guido Cavalcanti. stimato da Elisabetta, atto agli
affari, al quale la regina affidava l�incarico�
di risolverla, e fu brillantemente risolta con il trattato di Cateau Cambresis, (1559)
e successivi accordi tra Inghilterra e Scozia.
A questo trattato avevano partecipato le
delegazioni di Francia, Spagna e Inghilterra e con esso si concordava: la
restituzione da parte della Francia al duca di Savoia e alla Spagna di quattrocento
citt� e terre; e, poich� nei trattati di pace si concordavano sempre dei matrimoni,
si era pattuito il matrimonio di Filippo con Isabella, figlia di Enrico II e, per il duca di Savoia, il matrimonio con la sorella
di Enrico, Margherita� (queste nozze erano
state infsuste a causa della morte di Enrico durante
un torneo). Si era parlato anche del matrimonio di Elisabetta con l�arciduca
Ferdinando, ma le cose, come tutti i progetti di matrimonio di Elisabetta,
erano andate per le lunghe, senza alcun risultato.
Il�
Delfino, per la morte del padre diveniva con Maria re e regina di
Francia di Scozia, e inoltre essi si appropriavano del titolo e delle armi
d�Inghilterra e d�Irlanda, mentre Francesco (II)
mandava in Scozia� truppe francesi per
difenderla da eventuali attacchi inglesi.
Per Calais�
si decideva che la citt� rimanesse alla Francia per otto anni, trascorsi
i quali sarebbe stata restituita agl�inglesi dietro un esborso di un milione e
mezzo di lire-tornesi e durante questi otto anni, tra Francia, Scozia e
Inghilterra, si sarebbe mantenuta la pace; e, nel caso francesi o scozzesi
avessero fatto guerra all�Inghilterra, Calais sarebbe tornata agli inglesi.
Con ulteriori accordi (1560) Francesco II con Maria, si impegnavano a rinunciare all�uso di tutte le
insegne e iscrizioni che li indicavano come re e regina d�Inghilterra e
d�Irlanda (ma Maria in cuor suo non rinuncer�, fino alla morte, ad aspirare al
regno inglese) e, relativamente al Governo della Scozia, si stabiliva che
questo dovesse essere assunto da un Consiglio di dodici cittadini scozzesi,
eletti nel numero di ventiquattro dal Parlamento e tra costoro Francesco e
Maria ne avrebbero scelto sette e gli altri cinque sarebbero stati scelti dal
Parlamento; oltre a una amnistia generale per coloro che erano nelle carceri;
inoltre tutte le truppe francesi dovevano
abbandonare la Scozia, con divieto per il re e la regina di inviare altre
truppe, senza espressa autorizzazione del Parlamento.
Quanto alla religione si stabiliva che ogni
scozzese potesse vivere secondo i propri sentimenti religiosi, senza poter
essere moleststo dal Consiglio.
Tutto ci� costituiva una vittoria per
Elisabetta che, cacciando i francesi dalla Scozia, come era stato scritto, �si liberava dei serpenti che la mordevano
nel petto e li passava a coloro che la vedevano regnare con tanta pace
all�esterno e senza alcun disturbo all�interno�, nonostante avesse preso la
risoluzione di togliere di mezzo il papato, con la decisione che le rendite e i
censi ecclesiastici non dovessero essere pi� mandati a Roma ma dovessero essere
versati alla monarchia mentre lei aveva preso il titolo di Governatrice della Chiesa.
Questa pace era vergognosa per i francesi che,
come a Roma diceva una �pasquinata, mentre i francesi avevano dato a Elisabetta una �guanciatella�,
con la ritenzione di Calais, Elisabetta aveva dato un gran calcio ai francesi
scacciandoli con vergogna dalla Scozia.
Nel mese di dicembre di questo stesso anno
Francesco II moriva a diciassette anni appena
compiuti, lasciando Maria vedova di diciotto anni.
Elisabetta aveva messo la pace tra protestanti
e cattolici, distribuendo le cariche nel proprio Consiglio tra gli uni e gli
altri, tra i quali i principali �consiglieri
erano Thomas Howard, duca di Norfolk e il conte Henry Fitzalan
di Arundel, ambedue cattolici.
Per i rapporti altamente ipocriti tra Marie ed
Elisabetta, quando questa aveva saputo che Maria dalla Francia se ne stava
tornando in Scozia, aveva predisposto un tentativo per farla prigioniera
durante la sua navigazione verso la Scozia, mandando delle navi, ma il tentativo
non era riuscito; non appena Maria giungeva in Scozia, le mandava una superba
ambasciata con il conte Arundel, per congratularsi del suo arrivo in Scozia e per la sua stretta
amicizia con lei e con la Scozia. Maria che aveva prestato fede a queate espressioni di affetto di Elisabetta e ricambiava con
una sua ambasciata, mandandole un meraviglioso diamante a forma di cuore, come
prova della sua fede nei suoi confronti �che
sar� sempre pi� ferma e pi� chiara del diamante stesso�. Ma nel suo stemma continuava
a mantenere le insegne dell�Inghilterra!
�
SFARZO E SPESE
DI ELISABETTA
LE SUE RISPOSTE ALLE
PROPOSTE DI� MATRIMONIO
VISITA
A CAMBRIDGE E OXFORD
�
|
A |
bbiamo
visto come sin dalla incoronazione Elisabetta amasse lo sfarzo; per le spese
sostenute per la Corte e per sovvenzionare gli ugonotti francesi, dovette
chiedere il finanziamento al Parlamento, dove aveva il pieno favore della
Camera Bassa. Questa, che nella regina vedeva un amore straordinario verso il
popolo, chiudendo gli occhi per le spese della Corte, aveva disposto (1565) il
versamento di cinquecentomila sterline; nello stesso tempo, volendola vedere
sposata, aveva mandato una delegazione di trenta parlamentari per pregarla di
voler risolvere il problema del suo matrimonio; la preccupazione
del Parlamento era che se fosse venuta a mancare, non vi erano eredi e la
pregavano quindi di voler� nominare un
successore.
Lo
stesso Parlamento proponeva Edoardo d�Hastingues,
conte di Huntingdon o, in caso di� mancanza d�inclinazione verso quest�ultimo,
Thomas Howard, duca di Norfolk, ambedue di gran nascita, gran garbo e belt�.
La
regina, dopo aver ringraziato il Parlamento per il suo zelo e affetto nei suoi
confronti, dichiarava �che non aveva un
cuore cos� vile da rendersi suddita e obbligarsi a ubbidire a uno che era
obbligato a ubbidirla. Che non poteva risolversi a far compagno del suo letto
uno che doveva servirla a tavola; che voleva ben contentare i suoi popoli, ma
non in ci� che andasse a suo pregiudizio�.
Ritornati
i deputati con questa risposta, in Parlamento si cominci� a sospettare che la
regina avesse in animo un principe straniero capace di svegliare non meno
torbidi e guerre, di quello che aveva fatto Filippo, le cui calamit� erano
ancora fresche. Ma ancora maggior sospetti, ebbero i ministri stranieri, quando
vennero a conoscenza di questi particolari, ritenendo che Elisabetta propendeva
per un matrimonio con un principe straniero, che non solo avrebbe portato
gelosia, ma avrebbe portato turbamento alla pace di tutti i vicini.
Avvertita
la regina di tali sospetti, Elisabetta trov� il modo di rassicurarli facendo questa
dichiarazione: �Potevano gli uni e gli
altri mettere lo spirito in pace e togliersi qualsiasi apprensione, perch� se
fosse capitato di non sposare uno del suo Paese, ma straniero, sarebbe stata
sua cura scegliere un principe povero e di condizioni cos� mediocri e cos� poco
vantaggiose, che nessuno avrebbe avuto di che temere, risoluta a non spogliarsi
mai della sua autorit�; insomma, decidendo di passare a nozze, non voleva che
di lei si dicesse, se non che avesse preso un marito per il letto, non gi� un
compagno per il tromo�.
E
cos� tutti i tentativi di vederla sposata, riuscivano infruttuosi vedendosi
scorrere i giorni pi� fioriti della sua et�, senza sentirsi altro che un gran
piacere di scherzare con gli uni e con gli altri, come si vede scritto (era stato detto) nelle commedie di teatro, che spesso hanno due-tre
promessi mariti in trattativa, ma nessuno nel letto e nel cuore: che lo stile
di Elisabetta, era di dare buone parole a tutti ma in concreto sfuggire a ogni minima
soluzione.
Quando
il re di Svezia, al tempo della regina Maria, aveva mandato ambasciatori per il
figlio Erik, che poi �era divenuto re e
lei era tenuta in semi-prigionia, Elisabetta aveva risposto che �non vi era al mondo principe verso il quale
testimoniava maggior obbligo e maggior affetto per essere stato il primo a
domandarla, nonostante si trovasse in prigione e in condizioni calamitose, n�
poteva dimenticare di aver giurato di non sposare alcun principe se non l�avesse prima conosciuto e frequentato per
lungo tempo, ci� che le impediva di sposare un principe di tal fatta, che non
aveva mai visto n� conosciuto�.
E
buona parte delle sue risposte erano di questa natura, che erano intese a
scoraggiare qualunque straniero, mentre se si trattava di soggetti del suo
Paese rispondeva con la scusa che non voleva diventare� compagna di uno che fosse tenuto a ubbidirla,
n� con lei accomunare un suddito al trono.
Tra
gli aspiranti vi erano stati l�arciduca Ferdinando d�Austria e poi, pi�
insistentemente, l�arciduca Carlo, figlio dell�imperatore Ferdinando I; ma ci�
comportava che lei dovesse farsi cattolica, perch� un esponente della Casa
d�Austria non poteva sposare un�eretica. Alla fine era stata lei (1566) a
rompere gli indugi dicendo �di non poter
gustare le proposte nozze che le venivano dall�arciduca, per aver giurato di
non sposare mai alcuno senza vederlo prima negli esercizi sacri in pubblico,
della religione che lei professava�.
Per
distrarre il suo spirito dai problemi del regno, Elisabetta� decise di recarsi a visitare (1566) per due
mesi, un mese per ciascuna, le universit� di Cambrige
e Oxford, famose in tutta l�Europa. La mattina dava udienza a tanti letterati
ricevendoli familiarmente e con loro si tratteneva nelle varie materie
letterarie e di scienze; al dopopranzo andava ad ascoltare le dispute pubbliche
e la maggior parte della notte assisteva alle rappresentazioni teatrali
apprestate dagli scolari che molte persone scrupolose criticarono in quanto �la regina si era ritirata dalle
superstizioni di Roma, per compiacersi delle rappresentazioni di commedie e
bagatelle teatrali�.
Mentre Elisabetta era a Cambridge, dalla Scozia
era giunto l�ambasciatore Jacob Melvin che annunciava
il parto della regina Maria di un maschio, al quale era stato dato il nome di
Carlo Giacomo, con la richiesta di fargli da madrina; Elisabetta aveva gradito
la richiesta e avcva mandato �il cav. Henry Killigrew
di Edimburgo per congratularsi del parto e nell�accettare l�invito, pregava la
regina di accogliere al suo posto un�ambasciata, per non esporsi al gesto di
qualche ribelle e, tornando a Londra, inviava Francis Russel,
conte di Bedford come capo della solenne ambasciata
che la sostituiva per il battesimo.
Con il suo ritorno a Londra, prima nel
Consiglio reale e poi pubblicamente, non si parlava che del suo matrimonio e
dell�obbligo di nominare un successore e si facevano i nomi dei pretendenti che
erano Guglielmo Herbert conte di Pembroc, il conte di
Leicester e Guglielmo Somerset conte di Worchester, mentre William Cecil che era il suo personale segretario,
sosteneva le ragioni della regina, dicendo che un re avrebbe oscurato tutta la
sua autorit�; anche il suo medico personale, uomo di fama, forse su suggerimento
di Cecil, sosteneva che la sua �complessione�
era contraria al matrimonio, che avrebbe potuto metterla anche in pericolo di
vita; per questo la regina amava s� stessa, godeva del fasto, dei piaceri e
della sontuosit� e aborriva il matrimonio per non cadere in qualche lunga e
mortale infermit�.
In questo periodo era capitato a Londra Thomas
Howard, duca di Northfolk, il pi� considerevole
cavaliere del regno in nascita e dignit�, parente di terzo grado della regina,
il quale recatosi con gli altri signori da Elisabetta affrontava due argomenti:
primo, le faceva presente che il pi� prossimo a
succederle, tanto rispetto al padre, quanto rispetto alla madre era Giacomo di
Scozia figlio appena nato di Maria Stuarda e, secondo, le chiedeva il permesso
di sposarla.
A Elisabetta questa richiesta non era andata a
genio, in quanto non voleva che reggente del pupillo fosse un cattolico e
tantomeno marito di una regina cattolica, e inoltre non poteva permettere che
un uomo che avesse tanta autorit� in Inghilterra, se ne andasse in Scozia e
rispose alla sua maniera �che matrimoni
di quella natura bisognava ben maturarli e che gi� erano ventiquattro anni che
maturava le sue nozze, senza poterle risolvere�.
In incognito era giunto a Londra (1567) il
conte di Egmont, per proporre a Elisabetta il matrimonio del figlio di Filippo,
don Carlos, infante di Spagna che
sar� reso celebre dalle tragedie che saranno scritte su di lui.�
Egmont, nel colloquio avuto con Elisabetta
aveva fatto una descrizione fisica di don Carlos, diversa dalla realt�,
essendogli state attribuite belle fattezze di corpo e gentilezza di spirito,
con l�aggiunta che don Carlos non avesse alcuna inclinazione per gli spagnoli e
ottenendo dal padre i Paesi Bassi, questi avrebbero potuto ingrandire la
monarchia inglese.
Il principe inoltre, aggiungeva Egmont,
aborriva la religione romana e il suo animo era incline alla riforma della
Chiesa; Elisabetta ne fu tanto stimolata che, senza tener conto della
differenza di et� (nove anni) che la separavano da don Carlos, non escluse le speranze della sua buona
disposizione; ma, more solito, la
faccenda non ebbe pi� alcun seguito (del personaggio ne abbiamo fatto separatente una descrizione v. Schede, Don Carlos infante di Spagna).
Dalla
Francia, per Elisabetta,� giungeva
un�altra richiesta di matrimonio (1574); quella di Francesco Ercole, duca di
Alan�on (1555-1584), giovanissimo
figlio di Caterina de� Medici (aveva ventiquattro anni, Elisabetta
quarantacinque); la richiesta giungeva nel periodo in cui Elisabetta aveva come
favoriti Leicester e Harton.
Il giovane duca si era recato a Londra in
incognito; non non era bello e aveva il viso
deturpato dal vaiolo, come d�altronde lo aveva Elisabetta (avuto nel 1562), che
nascondeva le cicatrici con le creme; aveva il naso che sembrava diviso in due
e inoltre era basso, ma vivace e pieno di spirito, almeno cos� si era mostrato,
con i suoi amici che lo accompagnavano, durante la sua permanenza a Londra. Ambedue
si erano piaciuti e Francesco Ercole, aveva mostrato di non essere molto legato
alla religione, s� che Elisabetta aveva preso in considerazione l�idea di
sposarlo, nonostante la differenza di et�, e nonostante il Consiglio reale si fosse
espresso negativamente; passati dieci giorni tra feste, balli e corteggiamenti,
il duca era stato spinto a ripartire, e le luci sulle illusioni si
spegnevano.� ���
Nel
frattempo moriva Carlo IX (1575) e Caterina faceva chiamare
segretamente il figlio Enrico, che stava regnando in Polonia, per metterlo sul
trono di Francia. Preso il nome di Enrico III, era da
sposare, e Caterina, cambiando il precedente orientamento del matrimonio del duca
d�Alan�on, proponeva a Elisabetta, il nuovo re come
sposo, ritenendo che se non aveva voluto sposare un principe, avrebbe
certamente sposato un re (non aspettandosi la risposta che avrebbe dato
Elisabetta!).
Inviava� quindi una solenne ambasciata, affidata a
Enrico di Borbone, duca di Montpensier, che si era
recato da Elisabetta con un seguito di trenta persone; accolto dalla regina non
come ambasciatore ma come un fratello; la risposta di Elisabetta era stata: �Signor duca, non � mio pensiero maritarmi,
ma occorrendo, amerei prendere un principe per farlo re, che un re per farmi
principessa�; il duca part� e provvide a far sposare Enrico con la
principessa Ludovica di Lorena.
Dai Paesi
Bassi era stato richiamato il duca d�Alba, che aveva governato col pugno di
ferro, e in sua sostituzione, era stato mandato don Luis de Zu�iga y Requesens,
Gran Commendatore di Castiglia, di carattere ben diverso dal suo predecessore; era
stato mandato (1573) nei Paesi Bassi dalla Corte spagnola con l�intenzione di
fargli sposare la regina d�Inghilterra. Il �governatore era infatti �un signore attempato, nemico
dell�ambizione, buon cattolico e fedele al re Filippo ed Elisabetta era nell�et�
(trentatr� anni) in cui non avrebbe
potuto avere un marito pi� maturo e il matrimonio avrebbe potuto portar la pace
nelle Fiandre�.
Requesens aveva comunicato a Elisabetta le sue intenzioni
e buoni rapporti e in risposta aveva avuto altrettanta disponibilit�; ma in
segreto Elisabetta sovvenzionava i protestanti fiamminghi e li stimolava alla
rivolta contro il loro re. La risposta data da Elisabetta, era alla sua maniera,
con quell�entusiasmo che faceva intravedere la concretezza della realizzazione;
ma proprio� quando gli era giunta la
risposta, il commendatore colpito da una febbre maligna, passava a miglior� vita (1576); qualcuno gli aveva sentito
dire:- �Questa falsa Gezabel
(dalla forte personalit� e nel regno sostituiva il marito) d�Inghilterra mi ha ingannato; e �i suoi inganni mi hanno fatto servir male il
mio Signore�,��
In sua sostituzione (1576) era stato �mandato l�allievo di Requesens,
don Giovanni d�Austria, nominato Governatore dei Paesi Bassi dal re Filippo.
Dopo la battaglia di Lepanto (v. in Specchio
dell�Epoca, Lepanto ecc.) era in auge
l�ammiraglio don Giovanni, considerato il capitano del secolo, per la vittoria
contro i turchi (1571); ben fatto e dai modi francesi pi� che spagnoli,� era stato proposto a Elisabetta (nel 1572);
con allarme della Corte spagnola che temeva che Elisabetta avesse potuto
convertirlo al protestantesimo e potessero sorgere problemi con i Paesi Bassi,
che certamente sarebbero passati dalla parte di don Giovanni.
La proposta non ebbe seguito, ma si riteneva
che ambedue avessero potuto mantenere una corrispondenza segreta e nel caso di
un loro matrimonio, si temeva che le Fiandre fossero cadute nella dipendenza
dell�Inghilterra.����
Un�ulteriore proposta (1576) non ebbe alcun
seguito ed era stata oggetto di pasquinate a Roma e in particolare di satire
sulla circostanza che ambedue erano considerati bastardi. Don Giovanni, forse
sognando di diventare signore d�Inghilterra con il governo dei Paesi Bassi, nel
periodo in cui vi �governava, a Bruxelles
fu colpito da una febbre maligna, accompagnata da delirio (con trasporto di cervello), e moriva nel giro di tre giorni (1578),
con sospetto di avvelenamento da parte degli spagnoli, che cadevano in
particolare su Filippo, ei sospetti caddero anche su Elisabetta che non aveva
alcun motivo di farlo.
��
I PIRATI PONGONO
LE BASI DELLE
�COLONIE
�E DELL�IMPERO
�
|
E |
lisabetta superando il padre e il nonno era
stata una regina d�eccezione per le alte qualit� politiche e per l�intelligenza
con cui seppe servire il paese; ma la sua grandezza era dovuta al merito dei personaggi
di prim�ordine di cui si era circondata, senza distinzione nella religione da
essi professata: i due Cecil (William e Robert, poi conte di Salisbury, padre e
figlio), con tutti gli altri, erano preparati, ciascuno nel proprio campo, come
Burghley e Walsingham uomini di Stato, marinai come Drake, Hawkins, Forbiser, Raleigh e Davis, militari
come Norris, Vere, Howard, Montijoy,
Essex, Philippe Sidney.�
Il dispotismo di Elisabetta poteva esser pari a
quello praticato dagli zar in �Russia e dai
sultani in Turchia, ma aveva saputo far accettare agli inglesi il suo
assolutismo e malgrado le sue forme dure di governo, aveva mostrato di amare il
suo popolo e ne era stata fraucamcnte ricambiata ed
apprezzata; perch� la sua politica aveva saputo
rapidamente trasformare la Gran Bretagna da un paese di allevatori di bestiame
e di mercanti di lane, in un paese di industriali (i tessitori fiamminghi, emigranti per sfuggire alle persecuzioni
spagnole, avevano trovato rifugio tra gli Inglesi), di armatori e di navigatori
e� aveva dato la spinta decisiva per
costituire un dominio coloniale nell�America del Nord.
I corsari dell�Inghilterra facevano al
commercio spagnolo una guerra spietata; Hawkins nel 1567 era stato sorpreso e
battuto nella baia di San Juan de Ulloa, dal vicer�
del Messico; era scampata una sola delle sue navi comandata da Francis Drake, ardito
avventuriero che aveva giurato di recuperare le sue perdite prendendo le Indie
occidentali, dove la Spagna escludeva dal commercio tutte le altre nazioni. �
Nel corso di tre spedizioni aveva saccheggiato
la citt� spagnola di Nombre de Dios e nel
1570 aveva fatto un tale bottino, che nel 1577 pot�
partire dall'Inghilterra con cinque vascelli e centosessanta uomini.
La stessa regina aveva investito mille corone
in questa impresa di filibustieri; Drake aveva doppiato per primo Capo Horn e andava a saccheggiare tutte le citt� del Cile e del
Per� catturando un numero considerevole di navi; ma una squadra spagnola
l'attendeva al ritorno e per evitarla Drake ebbe l'audacia di attraversare
tutto l'oceano Pacifico e giungere in Inghilterra attraverso il Capo di Buona
Speranza (1577-1581).
Aveva impiegato tre anni ed era stato il primo
a fare il giro del mondo; portava alla regina ottocentomila lire-sterline, di
cui una piccola parte era stata data all'ambasciatore spagnolo, che reclamva la totalit�.
Elisabetta si era recata sulla nave di Drake
nominandolo cavaliere e Drake nel suo stemma aveva riportato un vascello con la
divisa: �Sic parvis magna� che
ricordava le sue grandi imprese. John Hawkins, parente di Drake, ammiraglio,
tesoriere di Elisabetta, si era reso celebre per lo sviluppo dato alla tratta
dei negri che in quell'epoca non era considerato un disonore come si era
ritenuto successivamente. Sei anni dopo (1586), Thomas Cavendish (1560-1592), rinnovava la circumnavigazione che era
preparata rispetto a quella di Drake che era stata tentata, con la stessa
fortuna.
Quando l�esploratore Walter Raleigh (1552-1618) scopriva le coste dell�America settentrionale (1584),
dava a quel territorio il nome di �la Virginia in onore di Elisabetta e
portava in Europa la patata che costituiva la pi� preziosa di tutte le
scoperte.
Presso il Royal Excange di Londra la spedizione di un
mercante in India (1599) aveva suggerito l�idea della costituzione della
�Compagnia deIle Indie�, con
privilegio concesso da Elisabetta (1600), con cui nell�India erano gettate le
basi del futuro Impero britannico.
Contemporaneamente,
il tono di vita degli Inglesi si elevava sensibilmente, l�obbligo del lavoro
era generalizzato in quanto il vagabondaggio era perseguito provvedendosi ai
disoccupati con la tassa dei p0veri.�
Per superare le restrizioni sul commercio dei prodotti
delle Indie, opposte dagli spagnoli (v. cit. Art. Carlo V� ecc. P. II), e per
appropriarsi dell�oro e dell�argento trasportato dagli spagnoli, come
abbiamo� visto, Elisabetta aveva
scatenato i suoi pirati; nel 1591� aveva
affidato a Thomas Howard, figlio del duca di Norfolk, nominato ammiraglio,
quattro delle migliori navi che avesse l�Inghilterra, la prima delle quali, si
chiamava �Vendetta� e l�altra �Diffidenza�, con sei altri vascelli
chiamati �pinazze�,
facendo vela verso il Nuovo Mondo e giunti alle isole Flores (Azzorre) dove si
erano fermati per rifornirsi di acqua era stato notato che cinquanta navi
spagnole stavano navigando verso di loro; Howard che si era reso conto di non
poterle affrontare, aveva preso il vento a vele spiegate, ma il viceammiraglio
che si trovava a terra, si era trovato uno smisurato galeone che aveva il nome
di �San Filippo� e sbarrava la strada
alla sua nave e gli toglieva il vento e comici� ad
assalirlo a cannonate; il comandante del galeone non aveva voluto che interevenissero le altre navi spagnole, volendo prendere da
solo la nave inglese; ma a causa della ostinazione della nave inglese, si
avvicinarono altri quattro vascelli� che
in due ore scaricarono ottocento cannonate, senza per� prenderla� e giunta la notte la tennero assediata. La
mattina seguente, essendogli rimasto un solo barile di polvere, il
viceammiraglio che aveva molteplici ferite, essendogli bastato essersi difeso
per quindici ore di combattimento, ritenendo pi� opportuno il gesto della
disperazione, piuttosto che darsi prigioniero agli spagnoli, comand� al
cannoniere di mandare a picco la nave. Il cannoniere si mostrava d�accordo in
quanto riteneva che gli spagnoli, considerandoli eretici, li avrebbero
condannati al fuoco o alla forca e per loro era meglio colare a picco; ma il
comandante della nave mettendosi in ginocchio disse che a questo modo sarebbero
morti come demoni e che era meglio la resa e avendoli convinti, pass� per primo
sul galeone spagnolo per trattare la resa. Il comandante. temendo che durante
le trattative il viceammiraglio e il cannoniere potessero ugualmente far
saltare la nave, ordin� che fossero tenuti in custodia. e presi gli accordi,
tutti gli inglesi furono trasferiti sul galeone.
L�ammiraglio spagnolo era don Alonzo de Bazan, fratello del
marchese di Santa Croce il quale nonostante gli accordi, aveva intenzione di
lasciar libero il comandante e impiccare il viceammiraglio, ma erano ambedue
feriti e morirono lo stesso giorno e in sostituzione del viceammiraglio fu
impiccato il cannoniere; tutte le altre navi inglesi proseguirono nella loro
rotta e non furono molestate.
La perdita di questa nave del valore di
centomila scudi, fu successivamente recuperata dagli inglesi, quando ventisei
galeoni colmi di straordinaria ricchezza di oro, argento e altre mercanzie
dovevano essere scortati dalle navi spagnole, ma furono sorprese da una
tempesta che ne affondava quattordici e le altre vagavano nell�Oceano e cinque,
le pi� ricche della flotta, la cui merce trasportata era stata stimata del
valore di un milione e mezzo di scudi, erano cadute nelle mani degli inglesi e
dell�ammiraglio Howard.
Sempre nello stesso anno (1591) dalle parti
della Barberia una nave inglese al comando di Thmas Whit con quarantacinque marinai era in attesa per caricare
delle mercanzie e il capitano aveva pensato di recarsi dove sapeva passassero
navi che andavano e tornavano dalle Indie e nel giro di due giorni incontr�
delle piccole navi spagnole ricche di merce che erano state scortate da dieci
galere che, ritenendole fuori pericolo, le avevano lasciate sole e per mancanza
di vento lo stavano aspettando; essendo due, pensarono di poter prendere la
nave inglese e la inseguirono; ma erano cariche di merce e avevano difficolt� a
manovrare, la nave inglese che aveva cinquantasette uomini, riusc� a prenderle
ambedue che avevano ottanta uomini ciascuna e un carico di
millequattrocentonove casse d�argento vivo; cento botti di vino di Spagna e
inoltre casse di breviari, messali e bolle pontificie che erano mandate ai
frati e preti delle Indie.
Leti che riportava il fatto, si meravigliava della
circostanza che una nave con cinquantasette uomini, ne avesse prese due con
ottanta uomini ciascuna; sta di fatto, egli concludeva che la nave era arrivata
con le due navi predate.
�
IL COMPLOTTO
DI BABINGTON
CONTRO ELISABETTA
IL PROCESSO
E LA CONDANNA
DI MARIA STUARDA
�
|
M |
aria Stuarda dalla sua segregazione continuava
a seguire i suoi progetti e complottare per la rivoluzione cattolica che, con
la collaborazione della Spagna, prevedeva l�invasione (*) dell�Inghilterra; ritenendosi
ancora titolare dei diritti sul regno di Scozia, Maria era irritata con suo �figlio Giacomo VI, protestante,
il quale aveva costituito una lega con la regina Elisabetta (1586).
Maria, aveva quindi deciso che se suo figlio,
prima della sua morte, non si fosse convertito alla religione cattolica,
avrebbe ceduto per testamento i suoi diritti di successione e lo stato e gli
affari del Paese, a Filippo II.
A Filippo chiedeva di prenderla sotto la sua
protezione, aggiungendo che lo faceva per la restaurazione nella Scozia, della
fede cattolica, di cui egli era un paladino; aveva quindi comunicato le sue
decisioni all�ambasciatore di Spagna, don Bernardino Mendoza.
Don Bernardino, che era al corrente di tutto
ci� che si tramava in Inghilterra e Scozia, da tempo era informato del progetto
di assassinare Elisabetta e aveva comunicato a Filippo che vi erano quattro importanti
personaggi che avevano accesso a Corte e avevano giurato di farlo, col veleno o
col pugnale; e glielo avrebbero comunicato al momento opportuno, per essere
soccorsi in caso di necessit�.
Capo di questa cospirazione era Antony
Babington, gentiluomo di Dethick, nella contea di
Derby; di buona nascita, con una considerevole fortuna, spirito vivo, molto
istruito e molto legato alla religione romana, con stretti legami con la pi�
brillante giovent� londinese.
Per mezzo dell�arcivescovo di Glasgow, egli si
era legato alla causa della regina di Scozia, divenendo suo devoto partigiano e
cavalleresco servitore e per due anni Maria, quando era sotto la sorveglianza
del conte di Shrewsbury, che gliela consentiva (la corrispondenza raggiungeva i
cattolici di Francia, tra i quali gli immancabili fratelli, duca e cardinale di
Lorena), si era servito di lui come intermediario della sua corrispondenza. �
I cospiratori che ritenevano che l�assassinio
di Elisabetta dovesse avvenire dopo l�invasione, si erano ricreduti in quanto
si erano resi conto e avevano deciso che essa dovesse avvenire prima dell�invasione;
ci� che rese necessario coinvolgere nel complotto altre cinque persone tra i loro
amici; incaricato dell�assassinio era il capitano John Savage.��
Babington frequentava Francis Walsingham,
ministro e segretario di Stato di Elisabetta e, per fugare ogni sospetto, gli si
era audacemente presentato offrendogli i suoi servigi; ma Walsingham ugualmente
insospettito, aveva dato ai suoi uomini l�ordine di pedinarlo.
Maria, dal castello di Chartley
dove si trovava, riprendendo il rapporto con Babington, gli inviava una lettera,
con cui si rivolgeva a lui come al �suo
grande amico�. Babington le rispondeva con un lungo dispaccio cifrato (6
luglio), rivolgendosi a lei come la sua �carissima
sovrana� e le riferiva che si stava occupando della sua liberazione, conformemente
al desiderio dei principi cristiani suoi alleati; egli si impegnava a servirla
fino alla morte, con aggiunta, nella lettera, �di ulteriori particolari riguardanti la sua
liberazione.
Maria a sua volta gli rispondeva, soffermandosi
su particolari della sua liberazione dalla sua prigione di Chartley
e ancora altri particolari (Marie Stuart,
Mignet, Paris 1852): Walsingham
che aveva un ottimo servizio di spionaggio, era informato dal cattolico Gilbert
Gifford, a conoscenza dei sostenitori di Maria partecipanti
alla cospirazione, che erano trentanove, riferendogli i loro nomi; tutto era
stato riferito a Elisabetta che spaventata dal progetto dell�attentato contro
la sua persona e della invasione del regno, volle che si procedesse
immediatamente agli arresti. ���
Walsingham faceva arrestare il prete John Ballard, Babington e Savage e
tratt� Maria come loro complice; lei, ignara del loro arresto, era a caccia
quando le fu annunciato l�arresto di Babington. �
Maria fu trasferita al castello di Tixall dove, per diversi giorni fu tenuta in una piccola
stanza, mentre dal� castello di Chartlay erano state prese tutte le sue carte e portate a
Elisabetta. Riportata al castello di Chartlay, aveva trovato
che era stato frugato dppertutto e indignata e
piangendo disse con il suo solito orgoglio: �Due cose Elisabetta non potr� mai togliermi, il sangue reale che fa
battere il mio cuore per la religione dei miei padri�.
Il processo ebbe inizio solo contro Babington, Savage e Ballard e i loro quattro
complici Barnewell, Tilney,
Abington e Tichbourne,
condannati (20 Settembre 1586) come cospiratori alla pena prevista nei casi di
alto tradimento, che consisteva nello sventramento da vivi, in presenza del
popolo.
Burghlay e Walsingham avevano ritenuto fare, separatamente
da quello ai ccospiratori, il processo alla regina; Maria
fu quindi trasferita al castello di Fotheringay, dove
fu insediata l�Alta Corte che l�avrebbe giudicata.
Il processo si svolse fondamentalmente sulla
base della corrispondenza intercorsa tra Maria e Babington e da questo riconosciuta,
e sulla testimonianza dei segretari della regina, Nau
e Curle. Ma Maria durante il processo aveva opposto
che si trattava di copie e non dei documenti originali: inoltre aveva inutilmente
protestato per aver diritto a un avvocato che potesse difenderla oppure credere
alla sua parola di regina. Non le fu riconosciuto n� l�una n� l�altra. Maria
inoltre aveva rifiutato di riconoscere la giurisdizione alla quale si intendeva
sottometterla a giudizio, ritenendo impossibile condannare al patibolo una
regina, in esecuzione di una sentenza di soggetti incompetenti, di un�altra
regina.
Ma il processo prosegu� ugualmente; nella sala,
tra tutti i giudici seduti in base alla dignit� di ciascuno, vi era anche il
posto riservato per la regina, rimasto vuoto per tutta la durata del
processo;� questo era pi� alto del posto
riservato a Maria che fieramente protest� dicendo: �Io sono regina, sposata a un re di Francia e il mio posto dovrebbe
essere l�� e osservando tutti i lord e
consiglieri seduti, aggiunse �Ecco, vi �
un gran numero di consiglieri eppure� non
ve n�� uno solo per me�.
Il processo iniziato il 14 Ottobre, ebbe
termine il 25 successivo, giorno in cui i giudici si riunirono a Westminster
per deliberare; �avevano voluto ascoltare
di nuovo Nau e Curle, e
mentre a Fotheringay avevano sentito l�accusata senza
testimoni, a Westminster ascoltarorono i testimoni senza l�accusata e il
processo che non aveva seguito le giuste forme procedurali, ebbe termine con la
sentenza di condanna decisa lo stesso giorno.
La sentenza alla quale si volle dare una
parvenza di ufficialit�, fu sottoposta alla conferma delle due Camere del
Parlamento, riunite qualche giorno dopo, che non solo sanzionarono la condanna
della regina di Scozia, che, secondo quanto era stato scritto, �la vendicativa ma prudente Elisabetta non
intendeva che far perire con un atto di giustizia e di volont� nazionale�.
Per questa voglia nazionale di vendetta� e di fanatismo, si ringraziava la Provvidenza
(alla quale si attribuiscono tutte le atrocit� commesse sugli avversari), per
aver salvato la loro regina e la Nazione dalla cospirazione e dalla tirannia
romana; e tutti chiesero la punizione per la regina di Scozia per il suo detestabile
complotto e per tutto ci� che aveva tramato in precedenza.
Non solo, ma il Parlamento si riun� nuovamente
(18 Novembre) per confermare che la loro
regina avrebbe corso il pericolo di vita fintanto che fosse vissuta la regina
di Scozia.
Abbiamo
letto tante esecuzioni avvenute nella storia, ma la pi� straziante per le
manifestazioni di fede e d�innocenza e per come si era svolta la stessa esecuzione,
� stata questa di Maria Stuarda che, morta, come aveva scritto Jebb, da martire; e noi riteniamo, avrebbe dovuto essere anche
santificata.
Nei diciannove
anni di prigionia (1568-87) era stata al centro,
consapevole o non, dei vari complotti orditi�
per assassinare Elisabetta. Per l�ultimo, ordito da Anthony Babington si
trovarono prove (vi era chi sosteneva, falsificate), del suo diretto coinvolgimento
che la condussero al patibolo, sebbene lei avesse giurato di esserne estranea.
Era salita
sul patibolo� con la stessa disinvoltura
e la stessa dignit� con cui sarebbe salita sul trono; quando era sul patibolo,
il carnefice mettendosi in ginocchio le chiese perdono; lei rispose che lo
accordava a tutto il mondo. Affront� la morte con eroico coraggio e ammirevole
dolcezza; la sua cameriera Jeanne Kennedy, aveva preso dalla borsa un
fazzoletto ricamato d�oro e le aveva bendato gli occhi; lei si era messa in ginocchio
rimanendo dritta, pensando che l�esecuzione sarebbe stata, come in Francia, con
la spada, ma le fu spiegato che doveva poggiare la testa sul ceppo, cosa che
fece continuando a pregare� ad alta voce.
La morte fu
orribile perch� il carnefice, certamente emozionato, non aveva sferrato con
decisione al primo colpo, e l�ascia si era fermata sotto la testa, ferendola,
senza che lei avesse fatto alcun movimento; il secondo colpo aveva preso solo una
gran parte del collo; la testa fu abbattuta al terzo intervento e il carnefice,
dopo averle rimesso la parrucca che le �era caduta, la mostr� dicendo �Dio salvi la regina d�Inghilterra, la regina
Elisabetta�. Nel momento in cui presero il corpo per portarlo via e imbalsamarlo,
emerse un �catellino� (erano i cagnolini delle regine e dei
cardinali), nascosto tra le vesti della sua padrona, che non voleva uscire e
dovettero strapparlo con forza.
� stato l'episodio di questa tragica morte che
i numerosi poeti e drammaturghi, subendo il fascino della sua complessa personalit�,
hanno prevalentemente trattato in ogni secolo �(**).
�
*) L�invasione,�
o meglio, il tentativo di invasione fu organizzato dopo la esecuzione di
Maria (1588) per la conquista dell�Inghilterra da parte di Filippo II, con la costituzione e �La fine dell�Invincibile Armada� che pubblichiamo in Schede S.�
**)
Maria Stuarda non era stata una grande regina come Elisabetta, ma la sua
tragica vita e la sua morte accettata stoicamente, avevano suscitato una grande
impressione in Europa e aveva avuto tutti i crismi per ispirare poeti e
drammaturghi, dalla sua epoca fino a Charles Swinburne (1837-1909) autore di
una trilogia: �Chastelard, Bothwell e Maria Stuarda�. Si veda il prezioso Dizionario
di Opere Bompiani.
L�ULTIMA FASTOSA
�AMBASCIATA
DI CHARLES BIRON
�RICEVUTA DA
ELISABETTA
E LA SUA ULTIMA SFURIATA�
��
|
E |
nrico IV di Francia aveva
sposato (1600) Maria de� Medici, figlia del granduca Francesco e come
ambasciatore aveva mandato alla regina Elisabetta un�ambasciata con il
presidente della Camera di Parigi, Achille d�Arlay,
per annunciare il suo matrimonio; a causa di ritardi, quando l�ambasciatore era
arrivato a Londra aveva partecipato anche la nascita del delfino (futuro Luigi XIII), e presso la
Corte inglese si era ironizzato sulla circostanza che quando Enrico si era
sposato, la moglie era gi� gravida.
Elisabetta aveva saputo che Enrico si �era recato a Calais �e aveva mandato un�ambasciata con il conte di
Edmond, per congratularsi ufficialmente con il re per il suo matrimonio, ma il
motivo principale era quello di incontrarlo e lei si era recata nelle vicinanze
di Dover, presso una villa reale a Vignes,
e gli faceva chiedere dall�ambasciatore se, trovandosi ambedue a met� strada,
si potessero incontrare; non si pu� escludere, supponeva il Leti,
che Elisabetta avesse in animo di incontrarlo per riprendergli Calais: ma, alla
sua richiesta Enrico che era molto sospettoso, aveva risposto negativamente.�
L�ambasciata era stata allestita da Edmond �con tanto sfarzo che a Parigi non si era mai
vista una ambasciata con maggior magnificenza; oltre ai cento scudi al giorno
che gli venivano versati per coprire le spese, il conte che era ricchissimo, aveva
aggiunto anche del suo.���������������������������� ��
Gli sposi a loro volta, avevano ricambiato con
un�ambasciata non meno magnifica; dell�ambasceria era stato incaricato Charles Biron,
duca de Gantaud, maresciallo e ammiraglio di Francia,
che aveva allestito la pi� superba ambasciata che si fosse mai vista, recandosi
a Vignes, dove si trovava la regina.
Oltre all�importo di spesa giornaliera che gli
era stato assegnato di centomila franchi, di suo, Biron spese ventimila scudi,
pari alla sua rendita di un anno. Il suo seguito era formato da ventiquattro
staffieri, dodici paggi, centocinquanta domestici, sei abati, quattro
cappellani, centosettanta gentiluomini, ciascuno dei quali aveva due servitori
con livrea.
La regina che in questi casi non voleva essere
da meno, invi� a Dover per ricevere l�ambasciata, uno dei suoi principali
ufficiali con centocinquanta gentiluomini, riccamente vestiti, con oltre
quattrocento servitori in livrea; con trecento carrozze e quaranta carri per il
bagaglio, per riceverlo e assisterlo dall�arrivo fino alla partenza, come era
stato fatto con Edmond.
Tra i gentiluomini si trovava uno dei maggiori nobili
che era il conte d�Auvergne, che aveva chiesto e ottenuto
dal re, di seguire l�ambasciata in incognito; la regina aveva dato udienza a
Biron con i suoi gentiluomini, seduta sul trono sotto un ricchissimo
baldacchino, mentre lei indossava un abito arricchito di ricami d�oro e di
gemme per il quale avevano lavorato cento persone per tre settimane, con una
corona che era una delle pi� ricche poste sul suo capo. Elisabetta aveva dato
ordine al vice-maresciallo, che sostituiva il maresciallo Essex che era stato
decapitato. dicendogli: �fate tutto bene
perch� questo � l�ultimo ambasciatore che ricevo solennemente in udienza�.
Durante la conversazione tra la regina e
l�ambasciatore, mentre la regina si mostrava dispiaciuta del rifiuto del re per
l�abboccamento richiesto, Biron, nelle risposte, dava prova di prontezza e
destrezza per giustificare il diniego; Elisabetta poi era venuta a sapere della
presenza di un gentiluomo in incognito, e scesa dal trono (*) si era avvicinata
al Biron chiedendogli di mostrargli il gentiluomo in incognito; il conte che si
trovava vicino, fattosi avanti le disse: �Ecco
serenissima maest� colui che desidera far l�onore di conoscere e che dopo il re
suo signore non vi � persona al mondo per chi abbia maggior rispetto e
venerazione�. Dopodich� la regina tornata sul trono chiese a Biron di� presentarle tutti i nobili che lo
accompagnavano, e, cominciando dal conte d�Auvergne,
le furono tutti presentati (proprio tutti quelli che l�accompagnavano;
Elisabetta, inconsciamente, stava dando l�addio al mondo!), e uno dopo l�altro,
le baciarono la mano.
L�ambasciata non fin� qui, perch�
l�ambasciatore fu invitato con il suo seguito,�
a visitare Londra (a spese della regina) e tra le cose degne di essere
mostrate, fu condotto al Ponte di Londra, dove erano affisse le teste tagliate
dei malfattori, e gli venne mostrata la testa del conte di Essex.
Biron fingendo di non sapere chi fosse, chiese
cosa avesse fatto e gli fu risposto: �Per
aver cospirato contro la sacra persona della regina�; Biron replic�: �Ce ne vorrebbero di ponti per mettere le
teste di tutti quelli che cospirano contro i principi�. L�ambasciatore dopo
essere stato quattro giorni a Londra, torn� a Vignes per rientrare in Francia; la
regina, prima della partenza, �offr� una
cena a tutti i francesi e li alliet�, suonando al cimbalo una canzone francese;
il giorno seguente condusse tutta la comitiva a caccia, a cavallo. �
Non si era mai vista, scrive lo storico Leti, un�accoglienza verso l� ambasciatore e tutti i
francesi che l�accompagnavano, da lasciare attoniti i ministri stranieri e gli
stessi inglesi e ci� nonostante, come abbiamo visto, dal re Enrico fosse stato
opposto un rifiuto alla richiesta della regina, di un incontro. �
Prima di partire, Biron era stato ricevuto
privatamente dalla regina per l�udienza di congedo e Elisabetta gli aveva
parlato a lungo di Essex, delle inclinazioni che aveva nei suoi confronti e
della sua perversa ingratitudine che lo aveva perduto e aprendo un cofanetto
gli aveva mostrato il suo ritratto, dicendogli:- Ecco l�effige di quel perfido; se il re mio fratello (Enrico), si risolvesse a castigare a questo modo i
traditori del suo regno, sarebbe molto ubbidito. Queste ultime parole avevano
fatto sorgere negli ufficiali di Biron che lo accompagnavano, il sospetto che la
regina non lo ritenesse troppo fedele al suo re.�
Biron, rientrato in Francia, aveva raccontato
l�esito dell�ambasciata al re Enrico e pur descrivendogli i particolari del
Ponte sul Tamigi, non gli aveva riferito della testa del conte di Essex, di cui
il re era a conoscenza; per questo motivo, il giorno dopo lo fece chiamare e
gli chiese di riferirgli esattamente tutto ci� che era stato detto nelle
conversazioni avute con la regina, senza fare alcun cenno a ci� che egli era
venuto a sapere.�
Questo comportamento del re, era dovuto al
fatto che fin da quando aveva mandato Biron con l�ambasciata, sospettava della
sua fedelt� e delle cattive disposizioni che aveva nei suoi confronti per voler
provocare una rivolta di popolo e appropriarsi del potere; e infatti si scopr�
che da quattro anni egli tramava contro la corona e, processato, fu condannato
al patibolo, perdendo la testa come l�aveva persa il conte di Essex.
Robert Devereux, conte di Essex, era stato
una delle ultime fiamme di Elisabetta
che per avere la
met� dei suoi anni le aveva suscitato le maggiori tenerezze e sentimenti
materni e lei gli aveva lasciato tanto potere che Essex �aveva avuto la tracotanza di avere intenzione
di assumere le redini del governo; ma con Elisabetta, sempre vigile, �aveva fatto male i suoi calcoli, perch� il suo
complotto era stato scoperto e dopo essere stato processato era stato
condannato al patibolo (1601).
Elisabetta, come emergeva dal ci� che aveva
detto a Biron, sarebbe stata disposta anche a perdonarlo se Essex avesse
trovato il modo di chiederlo; cosa che Essex aveva fatto, ma era intervenuto un
evento fatale che aveva impedito che il messaggio pervenisse a
Elisabetta.
In un momento di tenerezza, Elisabetta aveva
dato a Essex un anello, dicendogli di conservarlo come pegno d�amore e ogni
qualvolta fosse caduto in disgrazia, mandandole l�anello, l�avrebbe richiamata
alla tenerezza e indotta a favorirlo. Essex quando era stata emessa la sentenza
che lo condannava e doveva essere firmata dalla regina, aveva dato l�anello
alla contessa di Nottingham per consegnarlo alla regina; la contessa ne aveva
parlato al marito, nemico di Essex, che le aveva proibito di consegnare
l�anello; Elisabetta non ricevendo la richiesta del favorito, aveva firmato� la sentenza di esecuzione.
Avvenne poi, che la contessa di Nottingham si
era ammalata ed era moribonda ed Elisabetta era andata a farle visita e la
contessa, presa da scrupolo, le aveva riferito dell�anello datole da Essex, che
non le aveva consegnato, chiedendole perdono. Elisabetta, allibita, proruppe in
un�ira furibonda, scuotendo la moribonda nel letto e gridando che solo Dio l�avrebbe
perdonata, uscendo quindi, precipitosamente dalla camera. ��
Da questo momento Elisabetta era stata presa da
una cupa e insanabile tristezza e non voleva udire parole di consolazione e
rifiutava anche di cibarsi; gemiti e sospiri palesavano un�interna afflizione;
giacque su un tappeto, per dieci giorni e notti, appoggiata a cuscini che le
portavano le fantesche; alla fine fu messa sul letto dove volle rimanere
vestita; furono raccolte le sue ultime volont� e con voce fioca aveva detto a
Cecil che voleva come successore un re e quando Cecil le chiese di essere pi�
chiara, disse che nessuno aveva pi� diritto del re di Scozia; poco dopo le mancava
la voce cadendo in un sonno letargico che dur� alcune ore e poi tranquillamente
spirava (24 Maggio 1603).
�
�
*) Elisabetta se le venivano le traveggole, non
si preoccupava di scendere dal trono con la corona, calpestando l�etichetta; una
volta infatti, infiammata da un diverbio con il conte di Essex, era scesa dal
trono per dargli uno schiaffo; l'impetuosit� del suo carattere si manifestava
con tratti di violenza; non era raro che percuotesse le sue damigelle d'onore; aveva
percosso una ragazza di nome Scudamore, spezzandole
un dito, ma era stato detto che l�incidente era dovuto alla caduta di un
candeliere; una volta, durante un diverbio, aveva fortemente pizzicato la guancia della moglie del
conte di Huntingdon, il quale se ne era rimasto cos� dispiaciuto
da scriverlo in una lettera (D.Hume).��������������������������������������������������������������������������
��
LA VITA LICENZIOSA DI
ELISABETTA DESCRITTA
DA MARIA STUARDA
E LA CRISI COLLERICA
AVUTA DOPO
LA SUA ESECUZIONE
�
|
A |
nzich�
placare e conciliare i suoi nemici, Maria Stuarda ignorando la prudenza, non
parlava che di appenderli o crocifiggerli, tanto da renderli ancor pi� acerrimi
nemici; per sua natura e per carattere era �portata ad esasperare gli animi, piuttosto che
rabbonirli.
Poco prima
del complotto di Babington, Elisabetta aveva affidato la sua sorveglianza al
conte di Shrewsbury �che le aveva reso la
prigionia pi� stretta e crudele; il conte aveva una moglie gelosa, che riteneva
che il marito fosse divenuto amante di Elisabetta e si sfogava con Maria, riferendole
tutto ci� che si raccontava di lei nella Corte e fuori della Corte.
E Maria,
per alleviare le sue pene, con eleganza, le aveva scritto una lettera in cui le
rinfacciava� tutto ci� che le era stato
riferito, ponendo una gioia estrema� nel
raccontarlo e sottolineando tutto ci� che potesse irritare la regina; e pur chiamandola
�buona sorella�, tornava anche sullo
stesso argomento, per affondare ulteriormente il dito nella piaga e ferirla nel
suo amor proprio, di donna e di regina.
Da questo
documento emergeva, sotto un�apparente benevolenza, un�ardente e segreta
vendetta di Maria che si attardava a raccontare a Elisabetta (durante i diciotto anni
di prigione, non si erano mai incontrate e non si conoscevano), tutto il male
che dicevano di lei, dei suoi incontri notturni, dei baci scambiati in
prossimit� delle porte, delle impudiche�
sconcezze, della sua dissolutezza, note a tutto il regno; della
ripugnanza per il matrimonio che derivava, precisava Maria, di voler rimanere
libera per� l'amore e poter avere la
libert� di poter cambiare a piacere i suoi amanti.
Per l'amicizia dalla quale era legata, le riferiva� che raccontavano, che neanche si accontentava
di due o tre amanti e si dava a strani personaggi ai quali finiva per rivelare
segreti di Stato, �... e, �che �rincorreva
Christopher Hatton, e� andava a trovarlo di
notte.
Anche David
Hume, aveva trattato l�argomento di questa lettera e aveva scritto che: �Elisabetta aveva fatto promesse di
matrimonio a un certo numero di aspiranti che sovente aveva ricevuto nel suo
letto; che aveva avuto la stessa
compiacenza con Simier (il simpatico agente di Francia che agiva per
il� duca d�Alan�on, ed era
entrato nei suoi favori); che Christopher
Hatton, che rientrava nel numero dei suoi amanti, si era disgustato di lei� a causa di tutte le sue tenerezze. Che la sua
avarizia era spinta al massimo e non si lasciava prendere n� dalla riconoscenza,
n� dalla beneficenza, ma non risparmiava alcunch� per soddisfare i suoi
capricci amorosi�.
Inoltre Maria,
�nella licenzisit�
delle sue espressioni, si dilettava a riferire a Elisabetta� tutti questi particolari ... che le avevano
riferito ... offrendo un quadro delle differenze morali che le dividevano
(ma Maria dimenticava le bassezze in cui lei stessa era caduta nel periodo
scozzese); non solo, ma riferendosi anche
al fisico di Elisabetta ... con la vecchiaia che avanzava e della sua Corte che
la metteva in ridicolo;� delle signore di
camera che si prendevano beffe delle sue pretese e la burlavano alle sue spalle.
Maria non ometteva nulla, n� le collere, n� l'avarizia della regina
d'Inghilterra che era spilorcia per tutto, all'infuori dei suoi amanti... �i
quali fuggono� e lei aveva rotto un dente a uno del suo seguito�.
E per non
far mancare nulla a ci� di cui Maria era a conoscenza, riferiva anche di
malattie incurabili che Elisabetta portava, che rimanevano segrete e che non le
permettevano di prendere uno sposo� e
che� esponendosi� al ridicolo di tutto il regno �credendo di avere un bel viso splendente
come il sole", tanto essa era vecchia, aggrinzita .... giustificava
questa sua sfrontatezza nel riferire cose per le quali aveva dovuto forzare la
sua mano e il suo dolore, per �soddisfarla
e obbedirla� (D. Hume, Histoire d�Angleterre,
Paris, 1839).
La lettera in
ogni caso, nella sua scrittura, era un pezzo letterario, dallo stile vivo e
rapido da vera scrittrice, da considerare una delle migliori del suo secolo. Elisabetta,
malgrado i suoi intrighi licenziosi, non era fatta come le altre donne e tutti
quelli che avevano aspirato alla sua mano erano finiti per essere ben
ingannati; sulla sua bellezza era inebriata dalle pi� stravaganti adulazioni
dei suoi cortigiani, che non rifiutavano il�
piacere di coprirla di elogi su questo argomento. E avevano l�abitudine
di dirle che la sua bellezza li abbagliava
come il sole, da non poterne
sostenere lo splendore.
La regina
di Scozia aveva anche saputo che Elisabetta avesse subornato sir Thomas Gerrard Rolston per� sedurla e ottenere i suoi favori, al fine di
cogliere l�occasione di ricoprirla d�infamia (Philar�te Chasles).
Dopo questa
lettera era seguito il processo contro Maria col quale Elisaabetta
non le aveva risparmiato alcuna piet�, e, come abbiamo visto, era finito con la
sua esecuzione, sebbene vi fossero state molte richieste, principalmente di �monarchi, per la concessione della grazia, di
cui Elisabetta non aveva tenuto alcun conto. ��
Maria le
aveva scritto anche una lettera patetica e nello stesso tempo terribile, per la
responsabilit� che attribuiva a lei sola, dicendole, tra l�altro: �Signora, rendo grazia a Dio, con tutto il
mio cuore, che ha fermato il noioso pellegrinaggio della mia esistenza. Non
chiedo che essa sia prolungata avendo gi� avuto molto tempo per conoscere le
sue amarezze. Supplico solamente Vostra maest�, di non
dovermi attendere alcun favore di qualche zelante ministro di primo rango
d'Inghilterra, di poter ritenere voi sola, e non altri, (responsabile)
dei benefici che seguiranno ... �.
Prima e
dopo questa esecuzione vi erano stati momenti durante i quali Elisabetta aveva
mostrato prima, la sua indecisione o riottosit� a firmare l�atto di esecuzione,
lasciando Maria, in attesa e in ansia per due mesi e mezzo e, dopo a esecuzione
avvenuta, l�escandescenza della crisi collerica da cui era stata colta, ma non
subito; per quattro giorni aveva mantenuto il silenzio, al quinto giorno era
stata presa da violenta collera e indignazione nei confronti del suo segretario
William Davison � �dal quale pretendeva che l�atto che lei aveva firmato, non avesse
dovuto consegnarlo al Cancelliere e che gli era stata data esecuzione a sua
insaputa, ed era stato ferito il suo cuore e attentato alla sua autorit�� (!).
Elisabetta
faceva quindi arrestare Davison che fu portato alla
Torre, cacciando dalla sua presenza il suo vecchio servitore Burghley, che
aveva consegnato il documento a Robert� Beale ed era stato maltrattato a tal punto da dimettersi da
tutti gli incarichi; la regina aveva coinvolto anche i suoi due favoriti,
Leicester e Hatton, per aver partecipato alla deliberazione del Consiglio
privato, che furono momentaneamente allontanati cadendo in disgrazia; l�unico a
salvarsi da questa �grand sc�ne� era stato Walsingham che si era� tenuto lontano dalla faccenda, il quale aveva
lamentato di essere stato colpito da indisposizione!
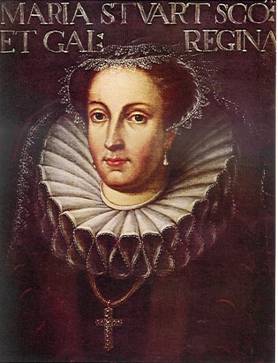
MARIA STUARDA
LA VITA PARALLELA
CON ELISABETTA
� SEGNATA DAL SUO
TRAGICO DESTINO
��
|
A |
ccanto alla
figura di Elisabetta, vi � quella altrettanto incancellabile di Maria Stuarda;
se Plutarco fosse vissuto al loro tempo, avrebbe scritto la loro vita
parallela; noi, nel nostro piccolo, proviamo a darne qualche elemento; ambedue,
in ogni caso, nel bene e nel male a distanza di secoli, si sono guadagnate il
ricordo dell�umanit�; ancora oggi sulle loro tombe non mancano fiori portati da
ignoti ammiratori, a testimonianza della�
loro immortalit�.� ��
Il giorno
del suo matrimonio Maria, in tutto il suo splendore, all'et� di sedici anni, �alta, bella e fin dalla nascita regina di
Scozia, avanzava accanto al delfino Francesco, nel suo sontuoso abito bianco dal
lungo strascico, tenuto da due damigelle; portava una collana di pietre preziose
di valore inestimabile �accompagnata da una
magnifica corona d'oro guarnita di perle, diamanti e rubini con al centro un carbonchio (cos� denominato il rubino
che superava i venti carati, dal valore di cinquecentomila scudi); nessun segno
indicava i giorni tragici che l�avrebbero colpita dopo solo due anni. �
Figlia del
re Giacomo V e di Maria Guisa di Lorena, per la morte del padre, che lasciava molti figli bastardi e lei, unica
erede legittima, dopo cinque
giorni dalla nascita Maria Stuarda era stata proclamata regina di Scozia, sotto
la reggenza della madre. Giacomo V era moribondo e quando aveva saputo che era
nata una femmina, pronunziava delle parole alquanto oscure in riferimento alla
corona� "Per figlia � venuta e per figlia se ne andr�"; egli infatti,
come tutt� i i
monarchi,� si aspettava un maschio e una
femmina sarebbe stata di cattivo augurio per la corona ... ma quelle parole
erano state piuttosto di cattivo augurio per�
Maria, che avr� tutta la vita segnata dalla sfortuna.
Il destino infatti,
le aveva riservato otto anni di vita carica di avvenimenti fausti; nel resto
sarebbero stati anni di vita, tragici, svoltasi a rincorrere un altro
trono,�� mentre non aveva saputo
mantenere il suo di Scozia e si perdeva a desiderare il trono d�Inghilterra,
che non riuscir� mai a raggiungere e la ridurr�, per diciannove anni, a una vita
di prigionia e alla tragica fine sul patibolo.�
A sei anni era
stata mandata presso la Corte di Francesco I (1494-1547,
v. in Art, Carlo V ecc.), dove nella dimora di Saint Germaine, le veniva
impartita una educazione all'italiana, con l'insegnamento del latino,
dell'italiano, dell'arte di scriver versi, della musica, danza; dedicando due
ore al giorno allo studio e alla lettura; tra i tredici e quattordici anni� in una sala del Louvre, in pubblico, aveva
sostenuto una tesi in latino.
Sposando (1558)
il delfino, Francesco di Valois (di quattordici anni), succeduto al padre, come
Francesco II (1559), diveniva regina di Francia, ma solo
per un anno, in quanto il giovane Francesco moriva l�anno seguente, lasciandola
�vedova dopo due anni di matrimonio.� Alla morte di Francesco II,
succedevano Enrico III (la cui successione non era
prevista e per questo Caterina de� Medici gli era stata data in moglie: v. in Art.
Diana di Poitier ecc.), e la moglie Caterina
diveniva regina (nomina ritenuta scandalosa per le origini della sua famiglia).
Caterina
aveva detto di lei: La nostra reginetta
scozzese non ha che da sorridere per far girare la testa ai francesi; ma i loro
rapporti, nel tempo, erano peggiorati in quanto Caterina non poteva soffrire
una nuora che la confinava nell'ombra e tra le due regine intercorrevano velenose
conversazioni; Maria un giorno le infligger� una ferita mortale, quando le
dir�: �Avete un bel da fare Madame,
voi� non siete e non sarete altro che la
figlia di un� mercante�; questa graffiante
offesa di Maria, era dovuta a quella mancanza di saggezza prudenza e umilt�,
che le mancheranno anche negli anni della maturit�. �
Caterina al
momento non aveva avuto nessuna reazione, ma essa peser� sulla decisione di
Maria quando dall�Inghilterra voleva tornare in Scozia e prendere le redini del
regno diviso, tra cattolici che parteggiavano per i francesi e protestanti che
parteggiavano per gl�inglesi. Ma le mire di Maria si rivolgevano al trono
inglese dove regnava Elisabetta, ritenuta figlia illegittima di Enrico VIII, di cui lei, come �legittima pronipote, si riteneva erede del
regno.
Maria era
una donna fiera e assolutamente priva di quella prudenza non solo nel
linguaggio, ma anche nel suo modo di agire, che solo in Francia le saranno
perdonate per la sua bellezza, non nella selvaggia Scozia, dove porter� lo
scompiglio tra i seguaci di ambedue le religioni. ���
Maria� doveva perdersi con i suoi stessi talenti e
con le sue manchevolezze, per le sue qualit� e per i suoi difetti, dei quali il
maggiore era la mancanza di freni che, nel�
suo caso, diventavano vera e propria sfrontatezza, come quella di aver
offeso le due uniche persone che non avrebbe dovuto offendere, la regina di
Francia, come abbiamo visto e la regina d'Inghilterra (con la lettera che le scriver�,
e vedremo pi� avanti, di cui se ne pentir� quando era troppo tardi), dalle
quali ricever� il �redde rationem�;
dalla prima, nessun aiuto per la sua liberazione durante la sua prigionia in
Inghilterra; vi era stato un solo tentativo da parte di Enrico III e Caterina, di aver reclamato con freddezza, presso
Elisabetta la sua liberazione: la ferita al cuore di Caterina era una ferita
che non poteva rimarginare; con la seconda perder� la testa ... anche se andr�
incontro alla morte con dignit� e coraggio.
Ma il suo
primo contatto con la Storia (appena sposata) trad� i difetti del suo
carattere, istintivo, violento, assolutamente impotente a dominare le
emozioni:� era stato proprio con
Elisabetta (indirettamente), che segnava l'inizio di un rapporto velato di
ipocrisia, ma che nel tempo si riveler� tragico.
Come
abbiamo visto, con il marito Francesco, prima del matrimonio erano stati presi
accordi in base ai quali Maria, avrebbe eliminato dal suo stemma e
arbitrariamente inserite, le armi
d'Inghilterra e Irlanda; ma, violando gli accordi Maria non le aveva
eliminate.
Questa
eliminazione era stata decisa con nuovi accordi con la Scozia, (trattato di
Edimburgo), che doveva essere firmato da Maria; Elisabetta aveva mandato in
Francia l'ambasciatore Thronckmorton, con il trattato da ratificare.
Maria aveva
ricevuto l'ambasciatore con l'aria corrucciata al quale aveva detto
apertamente: �Gli affari del� regno in Scozia vengono mal condotti; mi
ritengono la regina, ma non mi trattano come tale; io non ratificher� questo
trattato e insegner� ai miei scozzesi il loro dovere".
�Madame, riprese l'ambasciatore, mi sembra di capire che non volete
rinunciare apertamente ad usare lo stemma della mia signora e sicuramente essa
non potr� ritenere certo il vostro benvolere nei suoi confronti�. Maria
rispose �I miei zii (il cardinale e
il duca di Lorena), hanno gi� dato la
loro risposta su questo argomento sul quale non voglio pi� sentirvi parlare�!
Tutto era stato riferito dall'ambasciatore a Elisabetta, che non dimenticher�.
In seguito Maria dichiarer�: �Nessuna
parola di pi� sulla possibilit� di una mia rinuncia alla corona. Prima di
acconsentirvi preferisco morire e le mie�
ultime parole da viva devono essere quelle di una regina di Scozia�. In questa frase piena di orgoglio in cui si
concentrava anche la fermezza del carattere di Maria Stuarda e il suo
attaccamento alla fede alla quale aveva�
immolato la sua vita, fa ritenere che le sue mire di togliere il trono a
Elisabetta fossero concrete e non ipotetiche come si era sempre dubitato.
Nel frattempo come successore di Francesco II, saliva al trono il fratello Carlo IX
sotto la tutela di Caterina de� Medici che diventava regina reggente, per cui Maria Stuarda, resasi conto di non poter
pi� rimanere nella Corte francese, decideva di partire per la Scozia.
Per il suo
viaggio di ritorno in Scozia, Maria, come aveva scritto Brantome,
era stata agitata da tristi presentimenti che riteneva come un viaggio di morte
e avrebbe desiderato cento volte restare in Francia come semplice regina dotaria; ma i suoi fratelli (sfrenati nell�ambizione di
appropriarsi del regno) l�avevano sollecitata a partire; lei quando la nave si
allontanava dal porto, appoggiando le braccia sulla poppa accanto al timone,
guardava per l�ultima volta la Francia e mentre grosse lacrime le scendevano
sul viso,� la salutava: Addio Francia, addio, Francia! ��
� �
LE PRIME
ESPERIENZE
NEGATIVE DI MARIA
CON KNOX IL TRIBUNO
RIFORMATORE DI SCOZIA
�
|
L |
�idea di
Maria era quella di restaurare il cattolicesimo nel Sud della Scozia e
combattere il protestantesimo della nobilt� del Nord e non appena metteva piede
in Scozia, commetteva il primo errore tattico, maldestro e presuntuoso, con il
terribile tribuno riformatore John Knox, che teneva in subbuglio tutto il paese.
La regina �lo aveva convocato, fidando sulle risorse
delle sue argomentazioni e sulla sua sciolta ed elegante eloquenza:- �Il vostro oltraggio contro il governo delle
donne (*), � pericoloso e violento; esso arma il popolo contro di noi che siamo
regina; voi avete commesso un fallo e un peccato contro il Vangelo che ordina
l�obbedienza e la benevolenza. Siate
dunque pi� caritatevole d�ora in avanti verso chi non la pensa come voi�.� �Signora� - aveva risposto Knox - se colpire l�idolatria e sostenere le parole
di Dio � incoraggiare la ribellione, io sono colpevole. Ma, se come io penso la
conoscenza di Dio e la pratica del Vangelo portano il soggetto a obbedire al
principe dal fondo del cuore, chi mi pu� biasimare? Il mio libro non � che
l�espressione di un�opinione personale ... �In fatto di religione l�uomo non � tenuto a
obbedire alla volont� del principe, ma a quella del suo creatore ... Maria:
Pretendete dunque che il popolo possa
resistere al re? Knox: Certamente se
il re supera i suoi limiti. Knox: Tutto
ci� che egli pu� chiedere � di venerare il re come un padre e se il padre cade
nella frenesia, lo ferma. Quando un re vuole sgozzare i figli di Dio, si prende
la spada, si legano le sue mani, lo si getta in prigione fino a quando non gli
sia tornata la ragione, Qusta non � disobbedienza �
obbedire a Dio�.
E cos� i
colloqui erano proseguiti e Maria esasperata dal suo sangue freddo, dopo aver
tentato la via della seduzione, del ragionamento, delle minacce, delle lacrime,
dei singhiozzi e dello svenimento, lo aveva cacciato via. Attraversando una
sala vicina dove si trovavano molte dame elegantemente abbigliate, egli si era
fermato e aveva detto (come Amleto a Ofelia): Ah! Belle dame, ecco una vita affascinante; se solamente essa potesse
durare e se andassimo in cielo con il velluto e con le perle. Ma la gran
briccona della Morte, � l� che vi afferrer�, vostro buon grado o mal grado, e
questa bella pelle cos� tenera, cos� fresca,�
la mangeranno i vermi; e questa piccola anima debole e tremante, come
potr� portare con s� le perle e l'oro, guarnizioni� e merletti, ricami e fermagli? Ma dalla
sala della regina era uscito un signore che lo aveva messo alla porta.
Knox continuer� a dirigere i suoi sermoni, misti
a sarcasmi e ingiurie contro i costumi della giovane Corte, contro i Guisa, la
danza, la musica e la vita licenziosa della regina. Maria cercava dal suo
canto, di guadagnarsi ugualmente le simpatie di Knox e quella dei protestanti,
ma le sue seduzioni non avevano successo; nello stesso tempo cercava di frenare
i cattolici che erano indispettiti dalla vita che lei conduceva alla maniera
francese, balli, concerti, passeggiate a cavallo, caccia, canti, poesie erano
comportamenti che ferivano il fanatismo degli uni e degli altri.
Il suo
carattere passionale le fece sempre seguire le ragioni del cuore e della sensualit�,
anzich� quelle del suo Paese, commettendo un secondo errore, quello di di sposare Henry Darnley, capo dei cattolici inglesi,
allacciando stretti rapporti con Filippo II di Spagna
e con il papa, che appoggiavano le sue mire di impadronirsi del trono
d�Inghilterra e dai quali si sentiva fortemente spalleggiata (Philar�te
Chasles).
*) Knox aveva scritto un libro
introvabile sul Governo delle donne, �Regiment of women�, Il governo delle donne, violento trattato
contro il mostruoso governo delle donne.
�
ALLA CORTE �SCOZZESE
GIUNGE �IL BEL DARNLEY
MALIZIOSO OMAGGIO
DI ELISABETTA
��
L
|
e cose erano a questo
punto, quando a Corte (febbraio 1565) giungeva Henry Stewart Darnley
(deliberatamente e maliziosamente mandato da Elisabetta), dall'aspetto di
adolescente (era diciottenne), pieno di grazia, slanciato e snello (Elisabetta
lo chiamava �yonder long lad-il lungo ragazzo�), biondo, senza
barba, dalla carnagione delicata e dalla bellezza incantevole (*).
Maria vedova da tre
anni, ne rimaneva colpita e, nonostante il suggerimento contrario di Elisabetta
(l'etichetta delle corti prevedeva il suo consenso), come per provocarla �(**), decideva si sposarlo.
Henry (1545-1567) era figlio di Mattew Stuart
conte di Lennox e Margaret Douglas, nipote di Margaret Tudor, sorella di Enrico
VIII, che, in prime nozze aveva sposato Giacomo IV, e in seconde nozze Archibald Douglas,
conte di Angus (***); Lennox aveva lasciato
l�Inghilterra ed era andato a vivere in Scozia.�
Prima della celebrazione
del matrimonio, Darnley aveva avuto un attacco di vaiolo e Maria (erano gi�
fidanzati) andava a passare le notti presso il suo capezzale ... durante le
quali i due fidanzati davano sfogo� alla
loro intimit�. �
A Corte il comportamento
della regina era considerato poco rispettoso per le convenienze, mentre Darnley
ancora convalescente, insultava i calvinisti, e facendosi beffe degli scozzesi,
insultava i borghesi, ritenendo di potersi permettere tutto perch�
amato dalla regina.��������
Del padre di Darnley si
diceva che non avesse un solo scellino ed era debitore di Lord Lethington per un prestito di cinquecento� corone e gli restava appena da dar da
mangiare ai suoi cavalli; e se la regina Elisabetta gli avesse sospeso i viveri
egli sarebbe stato ridotto all'estremo; e Maria era decaduta fino a questo
punto?
Maria appena giunta dalla Francia, portando le
abitudini francesi, aveva �offeso tutti
gli scozzesi, il popolo che viveva ancora in maniera semibarbara e la nobilt�
legata alla feudalit�; e aveva offeso Elisabetta, appropriandosi delle armi e
del titolo che le spettavano; ora offendeva nuovamente tutti sposando un� giovanottello debole, incerto corrotto e
disprezzato. La sua vita in Scozia,� dispendiosa, brillante e gioiosa, si svolgeva
tra balli, giostre, tornei, cene, partite di caccia e feriva e offendeva i
puritani scozzesi. E siamo ancora all'inizio di tutti gli errori che
Maria continuer� a compiere.
Tutti
erano contrari a questo matrimonio: Elisabetta, i signori, i borghesi, i
protestanti: Maria scriveva: ��il mio cuore�
piange per la mia personale�
misera situazione; Murray, il fratello naturale, le diceva che non
dava un bell'esempio di onest�. Lei lo aeva preso in
disparte, chiedendogli di firmare il foglio che conteneva il suo consenso al
matrimonio e il consenso a darle sostegno con tutte le sue forze. �Ma Murray non si decideva a firmare: �Bene! diceva Maria; avete letto; firmate se
siete un suddito fedele se non volete rendermi scontenta�. �Madame�, aveva risposto Murray, dopo un
lungo silenzio, �questa � una soluzione
d'azzardo e questa richiesta mi coglie�
alla sporovvista; che si dir� di una tale
perentoria improvvisazione? Che diranno gli ambasciatori e i principi
stranieri? Che dir� la regina Elisabetta con la quale state conducendo
negoziati proprio per lui, dalla quale state attendendo risposta? Consentire a
sposare un uomo che non sar� mai difensore del Vangelo (la cosa al mondo pi� desiderabile), un uomo che si � mostrato nemico, non
protettore dei riformati, mi ispira una ripugnanza invincibile. Dunque
rifiutate? Si Madame�, fu la
risposta.
Pianti,
collera, parole ingiuriose, minacce erano state la reazione di Maria; suppliche
e lacrime, furono inutili; il sangue freddo di Murray sconcert� Maria che lo mand�
via dalla Corte: Ritiratevi; siete un ingrato e mi pagherete questo insulto!
Dopo
aver sfidato a questo modo Murray, Maria passava a provocare Elisabetta; le
scriveva una lettera piena di eloquenza - riferir� sir Nicolas Thronkmorton - dispetto, furore, collera e amore: maestra
in questo genere di composizioni. Le diceva di aver avuto l'intenzione di
consultarla, almeno per salvare la forma, ma�
era decisa a procedere da sola e scegliersi (per suo conto! ndr.) uno sposo ed essere nei fatti,
regina! �����������
Sposare
Darnley significava minacciare i protestanti e la stessa Elisabetta.�� Darnley, primo principe di sangue inglese e
cattolico, riuniva tutti i cattolici attorno a lui; i protestanti tremavano. Erano
in tre singoli, contro tutti: Maria, Darneley e Riccio: una donna passionale,
un vecchio segretario e un giovane scervellato, la cui arroganza diventava
sempre pi� intollerabile.
Si
andava ammassando contro Darnley,� un�animosit�,
un pericolo estremo; la sua arroganza diventava intollerabile (riferiva
l�ambasciatore Thomas Randolph); per sopportare le sue� parole si�
doveva essere schiavi e sopportare i suoi oltraggi; non li risparmiava
per dimostrare la sua virilit� e non risparmiava le ingiurie della sua collera
a quelli che le accettavano.�� ������������������
Knox
pescava nel torbido: non faceva altro che denunciare l'adulterio, l'incesto, la
danza, la musica, le messe (cattoliche), l'idolatria, Roma, Babilonia, tutte le
iniquit� che si stavano abbattendo sulla Scozia: predicava con fierezza e senza
altra ambizione che quella di compiere la sua missione, mentre� la borghesia scozzese lo ascoltava
terrorizzata, senza piet� per le donne, senza condiscendenza per le signore,
metteva in campo la cupidigia, la vanit�, la bassezza, l'egoismo, la duplicit�.�
Era �questo il clima che si respirava in Scozia quando il 29 luglio 1565. alle sei di mattina, nella cappella del castello di Holyrood, indossando lo stesso abito nero� indossato al funerale di Francesco II, Maria la giovane e brillante regina (di ventitre anni), concedeva la sua mano all�adolescente Henry Darnley (diciannovenne) detestato dal popolo; finita la cerimonia Darnley le chiedeva di cambiarsi d'abito.
Questo
matrimonio era considerato odioso in tutto il paese; i nobili di Corte la detestavano,
i predicatori si appellavano alle sentenze di morte e il popolo, impaurito si
dava ai saccheggi, ai furti, agli assassinii, senza che la giustizia facesse il
suo corso. Maria si sentiva sempre pi� isolata e si affidava agli inviati dei
Guisa e ai cattolici, dai quali si attendeva una degna opposizione alla riforma (cit. Philar�te Chasles).��
����������������������������������������������������������
�
*) �Questi pregi esteriori erano rovinati
dall�inconveniente dell�alito, ma all�epoca non si teneva conto degli odori
personali per la mancanza di pulizia.
**)
Era l�intento di Elisabetta che faceva il doppio gioco, nel senso che
ufficialmente si mostrava contraria al matrimonio, mentre Maria riteneva che
sposandolo, Elisabetta le avrebbe lasciato il regno! ndr.
*) Maria Stuarda era a
sua volta nipote di Giacomo IV figlio di Margaret
Tudor ed era quindi cuginastra di Darnley, dal cui matrimonio era nato Giacomo
che sar� VI di Scozia e come vedremo, I d�Inghilterra
(1566-1625).
DAVIDE RICCIO
ASSASSINATO IN
PRESENZA
�DELLA REGINA
INCINTA
�
L
|
e persone di cui si corcondava aumentavano il suo discredito; Maria aveva come
valletti di camera un certo Mingo (indicato dall�ambasciatore di Elisabetta, Randolph)
e un piemontese di nome Davide Riccio (o Rizzio), di
bell'aspetto, divertente, divenuto suo segretario e a conoscenza di tutti i
suoi intrighi; impertinente come un parvenu,
altezzoso con i nobili, sgarbato con i borghesi, vestiva magnifici abiti,
sontuosi fino al ridicolo e ostentava un fasto insultante e presuntuoso.
In Scozia solo un uomo
aveva accesso alla camera della regina ed era il suo segretario Davide Riccio
che Darnley detestava, come italiano e come cattolico; Maria non si accorgeva
che una nuvola di odio si andava formando attorno a lei. Oltretutto Maria mancava
di prudenza e tendeva ad aver fiducia e legarsi con uomini spregevoli e
abominevoli che alla fine la tradivano, come il suo fratellastro Murray, al
quale rivelava i suoi piani segreti; questo li riferiva al suo ambasciatore d�Oselle, che a sua volta li riportava alla sua antagonista
Elisabetta che a questo modo era a conoscenza di tutti i suoi piani segreti, fino
ai suoi intimi desideri (Philar�te Chasles).
Maria
aveva una cieca fiducia in Riccio ed era sempre a suo stretto contatto a tal
punto da essere inserito nel numero degli amanti, ma� questa illazione � da considerare falsa, come
vedremo pi� avanti.
Dopo
il matrimonio, la regina era divenuta pi� attiva, cacciava Murray dal reame e
stringeva maggiormente i rapporti con la lega cattolica. Il papa inviava da
Roma la somma di ottomila corone, della quale per� se ne impossessa il duca di Northumberland.
Filippo II
dalla Spagna inviava ventimila corone che l'ambasciatore spagnolo Guzman de Silva teneva a disposizione della regina e della
religione cattolica.
Riccio,
per la predilezione della regina nei suoi confronti, diventava ancora pi�
potente; italiano detestato, vestiva da gran signore, aveva disponibili due
cavalli, due paggi e un seguito di gentiluomini. Darnley a sua volta rimproverava
alla regina la sua eccessiva condiscendenza verso il segretario mentre a lui
non venivano affidati affari di Stato; incominciava a ingelosirsi di Riccio e
chiedeva la sua parte nel governo del trono, che lei gli rifiutava con
decisione.
Maria
incominciava gi� a sentire la stanchezza del rapporto; Darnley la avvertiva e
furioso si dedicava alle distrazioni grossolane, all�alcol, al gioco, alla
dissolutezza, trattava la regina con durezza e insolenza anche in pubblico.
La
regina ora si pentiva del matrimoio e detestava
Darnley e tutto ci� che gli apparteneva; Darnley folle di gelosia nei confronti
di Riccio, entrava in un complotto di protestanti che intendevano assassinarlo.
Pare che il complotto fosse stato organizzato
da Elisabetta (ricordiamo che Murray quando era stato mandato via da Maria si
era recato difilato da Elisabetta!) e avrebbe dovuto provocare la deposizione
di Maria e porre il regno nelle mani di Murray e dei protestanti, sotto il nome
dell'impotente Darnley.
Sulla legittimit� (morale) dell'assassinio, erano
stati consultati Knox e Craig, i quali, da buoni fanatici avevano risposto che �la Chiesa doveva essere salvata a prezzo del
sangue di un idolatra� (Knox nelle sue Memorie
la definiva �meravigliosa tragedia�):
I calvinisti scozzesi, ancora oggi si
meravigliano che Knox, il loro idolo, avesse acconsentito all�assassinio di un
povero musicista (scriveva Philar�te Chasles).
�ll 6 Marzo 1566 alle
sette di sera, cinquanta uomini armati circondavano il palazzo di Holyrood,
bloccando tutte le strade; Darnley saliva attraverso una scala segreta che metteva
in comunicazione il suo appartamento con quello di Maria ed entrava nella sala
dove Maria cenava in compagnia di Riccio, Beaton, la
contessa d'Argyle e il commendatore di Holyrood; si sedeva
a fianco di Maria mettendole un braccio intorno alla vita e le sussurrava
parole di tenerezza.
All'improvviso si vedeva
entrare come uno spettro, un uomo interamente coperto da una armatura; era lord
Ruthwen; Maria� incinta di sette mesi si
alzava spaventata e gridava: Andate via!
Ho una questione con Riccio, rispondeva Ruthwen, tirando dal fianco la spada;
entravano i congiurati illuminando la sala con le torce; Riccio si attaccava
alla regina gridando in italiano e francese: Giustizia, giustizia, salvate la mia vita; madame,� salvate la mia vita!
Maria implorava invano
gli assassini; la tavola e le candele erano rovesciate; Carr de Faudonside
appoggiava la sua pistola sul petto della regina e Riccio era trascinato fino
alla porta della camera da letto, colpito da cinquanta pugnalate; il suo corpo
portava conficcato in mezzo al petto il pugnale di Darnley, riconoscibile dai
suoi ornamenti e cesellature; il corpo era lasciato in un mare di sangue.
Ruthwen rientrava nella
sala con le mani sporche di sangue e si�
gettava su una sedia vicino alla tavola; �prendeva una coppa, la riempiva di vino e
alzandola verso la regina le diceva: vostro marito ha fatto tutto. �Ah! E' cos� dunque, rispondeva la regina; Addio, dunque, lacrime; Al tuo momento,
vendetta!� (*).
Alla confusione e alle
grida del palazzo, i borghesi si armavano, era suonata la campana e alla porta
di Holyrood si presentavano seicento uomini; il re si presentava al prevosto e
gli diceva: �Non � niente; io e la regina
ci divertiamo�.
�Con il permesso di Vostra Grazia, vogliamo vedere la regina�,
diceva
il prevosto. �E io non sono il re�?
Diceva Darnley. �Ritiratevi con la vostra
truppa, ve lo ordino�. E il prevosto obbediva.
La regina incinta e sul
punto di partorire, prigioniera dei suoi assassini, tra i quali suo marito, se
ne fuggiva montando su un cavallo e andando a rifugiarsi a Dumbar, dal fratello
di Davide, Giuseppe Riccio, dove partorir� (19 Giugno 1566)� questo bambino, degno figlio di Darnley,
povero di spirito e ricco di vizi, miserabile e meschino come suo padre, che
sar� il futuro �Giacomo I; e Maria che aveva
il titolo di regina di Scozia, dopo aver partorito, diventava regina degli� scozzesi, vale a dire del popolo e non del
regno come la legge del reame stabilisce meticolosamente (Philar�te Chasles).
A Elisabetta, subito
informata dell'accaduto, riferiscono, come era stato scritto al suo segretario
Cecil �Che Riccio era stato assassinato
perch� trovato a dormire con la regina� precisando comunque �Che non fu mai vero�.
A tre mesi di distanza
dall'avvenimento, Maria, nonostante la dichiarazione di Ruthwen, rifiutava di
credere alla colpevolezza di Darnley; lei non poteva credere alla decisione di
assassinare il suo segretario sotto i suoi occhi. Darnley stesso negava e a
tutte le domande di Maria, egli rispondeva di essere innocente; che Rotwen, Morton e Carr avevano
tramato e che lui aveva rifiutato� l'idea
dell'assassinio. Cos� presentati, essi si irritano e presentano a Maria le
prove della sua complicit� con la dichiarazione firmata per sbarazzarsi
dell'italiano; la firma del re confermava la sua partecipazione. Lei si rese finalmente
conto della vilt� del marito, traditore verso di lei e verso tutti, traditore
del suo onore, spergiuro e infame, e pianse amaramente! I congiurati prendevano
un altro impegno, giurando sul Vangelo, di eliminare Darnley.
*) Dalla completa
corrispondenza pubblicata da William Robertson nella
sua �Storia di Scozia�, non risultano
riportati dettagli e parole pronunziate da Maria.
�
BOTHWELL
�LA NUOVA PASSIONE
DI MARIA E
L�ASSASSINIO
�DI DARNLEY
�
|
D |
opo
l�assassinio di Riccio, il
Consiglio reale aveva disposto di rinforzare il servizio di sicurezza della
regina incinta e la guardia del palazzo a Edimburgo era stata �aumentata, affidando il �comando a lord Jaques Hepburn, conte di Bothwell,
capo di una potente famiglia e protestante, che disponeva di grandi propriet� e
molti vassalli; era luogotenente delle frontiere, uomo temerario che aveva tutti i vizi, tranne l'ipocrisia e tanto
feroce, quanto Darnley era debole. ��
I rapporti della regina con il marito erano
freddi, tanto che Darnley non aveva partecipato al lussuoso battesimo dato da Maria;
nei viaggi che facevano per distrarsi, i nobili le portavano poco rispetto e
lei se ne lamentava, confidandosi con Bothwell,�
che la serviva con molto zelo.
���
In questo periodo si stavano verificando delle sommosse
che insanguinavano i confini tra la Scozia e l'Inghilterra e Bothwell era stato
incaricato di andare a ristabilire l'ordine e durante un corpo a corpo con il
capo dei rivoltosi che aveva ferito alla coscia con un colpo di daga, a sua
volta, era stato ferito; preso dai suoi, lo avevano portato nel suo castello
all'Ermitage, distante sei leghe da Jedbourg, dove la
regina presiedeva una assise giudiziaria.
Nell�apprendere del pericolo corso dal suo
fedele servitore, Maria (15 ottobre), sebbene incinta, montava a cavallo e si
recava a visitarlo attraverso una strada impraticabile� e assisteva, consolava e incoraggiava il
ferito, ma, al ritorno lei stessa si ammalava. Alcuni avevano pensato che vi
fosse un legame tra i due e che lei si fosse ammalata per gli eccessi di una
sfrenata passione alla quale si era data, per
il disgusto che provava per l'ignobile marito.
Ma non era stato questo l�inizio del loro
rapporto, compiuto invece con un atto di forza di Bothwell, che aveva
approfittato di un momento di intimit� in�
cui si erano trovati; le esperienze di Maria, avute prima con un
quattordicenne e poi con un diciannovenne, erano state quelle iniziali; con Bothwell
(abituato a una vita dissoluta a dire di Hume), che ne aveva otto pi� di lei, presa
con forza, si era trovata di fronte a sensazioni nuove e Bothwel,
risvegliandole la sessualit�, �si era
impadronito del suo corpo, non del cuore�, come lei stessa aveva scritto in
seguito; ma poi la passione le prender� anche il cuore e idealmente la testa (*),
che la porteranno verso tutte le sue �successive sventure!���������� ��
E� in questo periodo che
Maria si univa ai nemici di Darnley, vale a dire Murray, Bothwell, Huntly, Argyle e Maitland segretario di Stato, i quali, segretamente riuniti
a Craigmillar (con la partecipazione anche Maria), �avevano deciso il divorzio e l�esilio di
Darnley, mentre Maria avanzava la vaga idea di ritirarsi in Francia. Ma Maitland le aveva detto: �Signora, qui siamo i principali rappresentanti della vostra nobilt� e
del vostro reame e troveremo certamente il mezzo per sbarazzarci di lui, senza
fare alcun torto a vostro figlio.�.�
Di fronte a queste
parole oscure e ambigue ma all�epoca era comune nelle corti esprimersi in
questo modo, era come dire, �disfarsi di
Darnley�; Maria rispondeva meravigliandosi flebilmente che �avrebbe preferito lasciare la cose come
stavano e pregare Dio nella sua bont�, di portare rimedio ai mali presenti e di
evitare ci� che in futuro sarebbe tornato a suo pregiudizio�. Al che, Maitland, approfittando della incertezza della regina, le
aveva risposto: Lasciate fare a noi;
Vostra Grazia non vedr� che buoni risultati, che avranno subito l'approvazione
del� Parlamento.
Non
appena questa ambigua conversazione aveva avuto termine, l'accordo dei
congiurati, redatto da sir James Balfour, era
sottoscritto da Bothwell, Maittland, Huntly e dallo stesso Balfour e
consegnato a Bothwell.
I congiurati ritennero a
tal punto di interpretare la volont� della regina, che uno dei personaggi
secondari, presente, Ormiston, avendo manifestato a Bothwell i suoi scrupoli,
questo gli aveva risposto: �Andiamo,
Ormiston (che in seguito finir� sul patibolo!) questa decisione era stata concordata da diverso tempo� a Craigmillar dai signori e dalla regina�.��
Henry
Darnley si trovava a Glasgow, dove era convalescente da una malattia che era
stata considerata come tentativo di avvelenamento da parte di Maria; la regina
si recava a trovarlo (22 Gennaio 1567); Darnley era debole e scusandosi, non
voleva riceverla: Lei gli diceva che certamente aveva paura e per la paura non
vi era alcun rimedio; ma entrava ugualmente nella sua camera da letto e avevano
un colloquio, dal quale emergeva che Darnley fosse a conoscenza del complotto
per assassinarlo.
Al
diniego della regina, egli la metteva con le spalle al muro, dicendole che
l'unico modo per potersi salvare, era quello di stare insieme a lui; Maria gli
rispondeva di essere d�accordo e di aver portato una lettiga per trasportarlo a
Craigmillar e di non rivelarlo a nessuno; ma Bothwell ne era a conoscenza in quanto la casa
dove si erano recati, sebbene sconosciuta, era sua; piuttosto spoglia di
mobili, in quanto disabitata, con la �camera da letto di Maria sottostante a quella
di Darnley.
Maria
aveva offerto un ballo in maschera (6 Febbraio 1567) per il matrimonio di un
suo valletto di camera e dopo aver passato tutta la giornata con suo marito,
era con lui, quando nella casa entravano, senza farsi sentire (avevano le
chiavi), componenti della guardia del corpo di Bothwell, che portavano sacchi di polvere
esplosiva e dopo averli collegati a una�
miccia, andavano via; Maria, dopo aver salutato il marito, si recava
alla festa. �����������
Mentre
il paggio �di Darnley, Taylor, dormiva su
un cuscino, un rumore di chiavi svegliava Darnley, il quale metteva sulle
spalle nude una pelliccia e scendendo le scale seguito dal paggio; gli assasssini strangolano lui e il paggio, portando i due
cadaveri in un frutteto e lasciandoli sotto una muraglia.
Bothwell, presente alla festa, la abbandonava a
mezzanotte e dopo essere andato a cambiare il suo lussuoso costume, raggiungeva
gli assassini; al suo arrivo era dato fuoco alla miccia che provocava un�esplosione,
che faceva saltare la casa e svegliava la citt� addormentata. Dopo l�esplosione
Bothwell
se ne andava a dormire e faceva un sonno tranquillo; al mattino� il domestico gli comunicava la catastrofe ed
egli, sceso dal letto, gridava �tradimento�.�
La
complicit� di Maria, o la sua connivenza, era entrata nella generale notoriet�;
�Bothwell trionfante per l'assassinio, percorreva le strade a
cavallo, armato fino ai denti, seguito da cinquanta dei suoi uomini, con� la mano sul pugnale, dicendo alla gente �Se vengo a conoscere il nome di uno di
quelli che hanno attaccato questi manifesti ai muri, la mia mano sar� presto
lavata con il suo sangue�. Uno di questi manifesti diceva: �Addio gentile Enrico e vendetta contro Maria�.
A Maria che attraversava a cavallo la piazza del mercato, dicevano: �Dio salvi Vostra Grazia, se non � coinvolta
nella morte del re�. Il padre di Enrico reclamava l'inchiesta e accusava
Bothwell
dell'assassinio.
Dalla
Francia non solo i Guisa ma la stessa Caterina e dall�Inghilterra, Elisabetta,
condannavano il crimine che aveva destato esecrabile orrore in Europa, e
richiedevano, senza ritardo la punizione dei colpevoli; Knox, mentre se ne
fuggiva per nascondersi nei boschi, aveva chiesto �Rivelate e vendicate�.� �
Bothwell
era stato processato e assolto e si era anche offerto di provare la propria
innocenza col duello; nello stesso tempo. si parlava delle nozze di Maria, per
necessit� del governo e si riteneva favorito Bothwell, il quale, un giorno,
mentre Maria si stava recando con la sua scorta a Stirling, per visitare il
figlio, la circondava con i suoi uomini e la conduceva a Dunbar, quasi come
prigioniera.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
LE DISASTROSE
CONSEGUENZE�
DEL MATRIMONIO
DI MARIA CON BOTHWELL��
|
I |
l motivo di
questo rapimento non era chiaro e pare che Maria fosse d�accordo; era loro
intenzione sposarsi, ma Bothwell era gi� asposato con la sorella del conte di Huntley
e si rendeva necessario l�annullamento del loro matrimonio, che fu pronunciato per
adulterio, per il quarto grado grado di parentela che
univa Bothwell alla moglie.
Dopo avergli
comcesso il titolo di duca di Ornay,
Maria� sposava Bothwell (15 Maggio 1567),
con una semplice cerimonia, alla quale avevano assistito pochi nobili in quanto
officiata da� un vescovo protestante, ci�
che aveva aumentato i sospetti sulla sovrana, per l�assassinio del re.
Non solo,
ma sorgeva il sospetto che Bothwell volesse impadronirsi del principe fanciullo,
per cui un gruppo di nobili� riuniti a
Stirling si erano confederati in una�
lega con a capo il conte d�Athole e con i
conti d�Argyle, Morton,
Marre e Glencairn, ai quali se ne unirono altri (**),
formando un corpo di ottocento cavalieri che si scontrarono a Carberry Hill, a sei miglia da Edimburgo, con il corpo
della regina, che vi partecipava con Bothwell.
Maria si
accorse subito che i suoi non approvavano la sua causa e non si mostravano
disposti a versare il loro sangue per quella contesa e la regina non trov�
altro da fare �che offrirsi ai
confederati; condotta prigioniera e confinata nel castello di Lochleven, posto in mezzo a un lago, fu costretta ad
abdicare in favore del figlio Giacomo.
Bothwell,
come scriveva D. Hume, non aveva dato alcuna prova di arditezza ed era fuggito
prima nel suo castello a Dunbar; successivamente si imbarcava per le Orcadi,
dove visse per qualche tempo di pirateria; poi si recava in Danimarca, dove era
arrestato e messo nelle prigioni, impazziva morendo dieci anni dopo (1578).
Elisabetta informata di tutto ci�
che stava avvenendo dal suo ambasciatore Tronghmorton
e commossa per la sorte di Maria, lo incaric� di presentare tutte� le sue rimostranze ai confederati, per il
trattamento che stavano riservando alla regina, alla quale l�ambasciatore
riferiva della disponibilit� di Elisabetta a prestarle aiuto.
Maria riusciva a fuggire dalla
prigionia (Walter Scott ne aveva fatto un piacevole racconto), e, tenendo conto
della disponibilt� ultimamente mostrata da Elisabetta
a prestarle aiuto, si imbarcava su un battello di pescatori a Galloway, approdando a Wirkington
nel Cumberland, recandosi al castello di Carlisle, a
trenta miglia di distanza, da dove mandava un messo per avvertire Elisabetta del
suo arrivo, chiedendole il permesso di visitarla.
Ci� costituiva una vera sorpresa
per Elisabetta, a causa dei problemi di carattere politico che le aveva subito rappresentato
Cecil, che avrebbero comportato la accoglienza di una regina sospettata
dell�assassinio del marito. Elisabetta decise quindi di mandare lady Scrope, sorella del duca di Norfolk, accompagnata dal
marito, lord Scrope�
e dal vice-ciambellano Francis Knollis, per rappresentarle
il dolore della regina per le sciagure che l�avevano colpita, ma al momento la
richiesta della visita non poteva essere esaudita, se prima non si scolpava
dell�assassinio del marito di cui era accusata.
Per questo motivo Elisabetta non
poteva mostrarsi indifferente, in quanto si trattava dell�assassinio di un
prossimo congiunto; ci� avrebbe comportato una indagine, per mezzo di due
commissioni, scozzese e inglese, per sentire le giustificazioni degli avversari
di Maria, che sarebbero stati mandati dal reggente di Scozia, Murray, al quale
Elisabetta aveva gi� fatto la richiesta.
Maria era scoppiata in lacrime, ma trangugiando
il rospo, non potette fare altro che rispondere, per mezzo di lord Herreis, che di buon grado avrebbe giustificato ogni colpa
di cui era accusata; ma l�impresa era ardua in quanto dovevano essere sentiti i
suoi avversari; in ogni caso Maria mand� a perorare la sua causa, presso i
commissari nominati da Elisabetta.
Intanto Maria, con la sua
eloquenza, insinuante e affabile, era riuscita a� convincere�
coloro che la circondavano, di essere innocente, dichiarando che era decisa
a chiedere soccorso ai suoi amici in Europa per vendicarsi dei suoi persecutori.
Riferiti questi particolari alla Corte, poich� Carlisle
era citt� di confine, Maria, oramai considerata prigioniera, ad evitare
tentativi di fuga, si ritenne opportuno portarla a Borton,
in una villa di lord Scrope nello Yorkshire.
Giunti i
commissari dalla Scozia, si riunirono agli inglesi (***) e nominati� gli assistenti Lidington
e lo storico Geoge Bucanan,
e furono trasferiti a Londra, a Hampton Court, per svolgere �e
loro sessioni.
La
Commissione, sulla base delle accuse del reggente, conte Murray, in possesso di
lettere scritte da Maria a Bothwell (che Maria gli aveva chiesto di bruciare ma
Bothwell non lo aveva fatto), e sulla base delle accuse del conte Lennox, padre
di Darnley, da cui emergeva la colpevolezza di Maria, invitata a discolparsi
dalle accuse, oppose un rifiuto e questo rifiuto fu opposto anche dai suoi commissari;
ma dopo che le sessioni erano state dichiarate cessate, �Maria accusava tardivamente Murray e suoi
complici, dell'assassinio del re; ma l�accusa era considerata come
recriminazio-ne dettata da rancore, e fu dichiarato cessato il compito dei
commissari, con un nulla di fatto.
Poich� la
citt� di Bolton, dove si trovava la regina di Scozia,
era attorniata da cattolici, ad evitare turbamenti, Maria era trasferita a Tutbury, nella contea di Stafford,
dove era consegnata in custodia al conte di Shrewsbury; da questo momento Maria
Stuarda rimarr� segregata come prigioniera, sebbene il termine ipocritamente usato
fosse �honourable custody�
(onorevole custodia).���������������
���
��
*) La
passione di Maria era arrivata al punto che
non le importava perdere la Francia, la Scozia e l'Inghilterra: piuttosto che
lasciarlo, con lui andrei in capo al mondo in jupon blanc, in sottoveste bianca (che
era quella usata normalmente a quel tempo). La
regina � folle e i nobili sono schiavi; la regina - aveva scritto de la Grange,
uno dei pi� considerevoli personaggi di Scozia, al duca di Bedford
- ha rovinato tutto �ci� che di onesto vi � in questo paese; ha
concordato (con Bothwell) di farsi
prendere (prigioniera) per compiere
il matrimonio.
�**) I lords
Boyde, Lindsay, Huntly, Semple, Kirkaldy de la Grange, Murray
di Tullibardin e il segretario Lidington.
��
***) Il reggente
conte Murray, il conte Morton, il vescovo di Okney, lord Lindsay e l�abatre Dunferlmling, con gli assistenti segretario Lidington e lo storico George Bucanan e destinata la citt� di York,
dove� convennero anche i commissari
inglesi, il duca di Norfolk, il conte di Sussex� e sir Ralph Sadler;
deputati dalla regina Maria. il vescovo di Ross e i lords
Herreis, Levingston e e Boyde, artbtra
la regina Elisabetta.� �
GIACOMO I DI SCOZIA
FINALMENTE
�RE D�INGHILTERRA
�E LA CONGIURA
DELLE POLVERI
�
|
E |
lisabetta,
quando era in vita, non aveva mai voluto fare il nome del suo successore e
aveva atteso fino all�ultimo momento per sussurrare a Robert Cecil il nome di
Giacomo di Scozia, come gi� aveva indicato nel testamento; Cecil volle
assicurarsene immediatamente e fece aprire il testamento, trovando conferma di
quanto gli aveva detto la regina; il Consiglio reale decise che Giacomo dovesse
essere dichiarato re d�Inghilterra come Giacomo I (1603-1625)
e la risoluzione fu comunicata al Sindaco di Londra.
Si
ritiene che Cecil, da una parte avesse mandato segretamente un messaggero a
Edimburgo per avvertire il re; mentre il Consiglio reale dava incarico a Robert
Carrey, figlio del conte di Hunsdon, di portare ufficialmente
la notizia al re di Scozia e invitarlo a recarsi a prendere possesso del regno.
Quando gli fu data la notizia Giacomo rimase impassibile, e nessuna alterazione era apparsa sul suo viso,
ci� che fa ritenere che egli gi� fosse a conoscenza della sua nomina.
L�anno
successivo alla sua incoronazione (1604), a Londra si diffondeva la peste, che in
un anno faceva trentamila vittime, su una popolazione di centocinquantamila
abitanti.
Con
il nuovo regno cessava la magia dell�epoca elisabettiana e si riaccendeva la
tradizionale lotta della nobilt� e della borghesia contro il sovrano, che
intendevano condividere il potere per mezzo del Parlamento e per impedire ai monarchi
d�imporre a loro piacere una determinata confessione religiosa.
Il governo di Giacomo I non
brillava dei grandi avvenimenti che si erano verificati sotto il regno di
Elisabetta, alcuni dei quali, iniziati sotto Elisabetta, si erano esauriti o
avevano proseguito fino al loro esaurimento.
Il suo assolutismo si scontrava
con il Parlamento, dove la borghesia era divenuta potente in seguito alla estinzione
della feudalit� e all�arricchimento conseguito dalla industria e dai traffici
(*). Inoltre Giacomo si era dovuto barcamenare tra due popolazioni, quella
scozzese ancora arretrata e legata al feudalesimo e quella inglese pi� avanzata,
oltre a una miriade di sfaccettature religiose che derivavano dai due rami
principali del cattolicesimo e protestantesimo e in ogni caso si fondavano
tutti sullo stesso principio di odio che li spingeva alla eliminazione fisica dell�avversario
come si vedr� pi� avanti, �nella
descrizione della congiura delle polveri.
Giacomo
era di educazione presbiteriana e sua intenzione era di unificare la
popolazione dei due paesi in un�unica confessione religiosa; in Scozia John
Knox, dopo essere stato a Ginevra, aveva perfezionato le sue idee religiose con
quelle calviniste che si erano affermate in base al sistema presbiteriano, (da presbuteros,
anziano) (**), intermedio con l�episcopalismo;
mentre tra i calvinisti inglesi si distinguevano i �godly-puritani�, che si consideravano �uomini di Dio�, in quanto volevano
purificare la Chiesa inglese da ogni permanenza cattolica. �
In
Inghilterra dopo la prima riforma introdotta da Enrico VIII,
con la elezione di Elisabetta, era stato approvato l� �Atto di Supremazia� (1559) col quale era eliminata la legislazione
antiprotestante introdotta da Maria e nello stesso anno era pubblicato un nuovo
�Libro della Preghiera Comune� e successivamente (1562)� erano approvati i �Trentanove Articoli di Fede� che con una visione unitaria di cattolicesimo,
luteranesimo e calvinismo, delineavano i caratteri della Chiesa Anglicana.
Giacomo
I sebbene �dotato di una vasta cultura
umanistica, era� stato bersagliato dalla
maggior parte degli storici che lo ritenevano debole di carattere� e aveva messo le finanze dello Stato nelle
mani dei suoi favoriti che avevano avuto�
esiti disastrosi. Di lui era stato detto, che �sopperiva con i maneggi e le insinuzioni e la
sua prudenza degenerava in pusillanimit��; sulla sua cultura, era stato
scritto che: �affettava l�erudizione ed
era istruito in cose inutili�; essendo versato in teologia, accettava volentieri
le dispute religiose ed �era stato
scritto �che si piccava sui dogmi, sulle
bolle e sull�origine del potere� (Cant�). Ma, aveva dato un saggio della
sua cultura scrivendo tre trattati.
Nel
primo, a seguito del �giuramento� che
aveva imposto ai cattolici, i quali �dovevano riconoscere l�autorit� reale e non tener conto della autorit� del papa che si
arrogava il diritto di nominare e destituire i monarchi, il cardinale Bellarmino, col nome di Mattia
Tortus, aveva scritto un libro contro il giuramento (***) e Giacomo aveva
risposto con l�Apologia, divenuto
rarissimo; inoltre, poich� egli credeva fermamente nel diavolo, aveva scritto
un trattato di Demonologia (****). Infine,
essendo un convinto sostenitore del potere. aveva scritto il �Basilikon Doron�, un trattato
sull�assolutismo e sul diritto del sovrano
e sulle origini del potere, che � stato attualmente dopo oltre quattro
secoli, dato alle stampe (*****).
I
cattolici che avevano confidato nella sua nomina per potersi riaffermare, si
erano sentiti traditi quando Giacomo I aveva lasciato in corso le disposizioni
vigenti contro di loro ed era stata presa la decisione di un attentato (congiura delle polveri) di ampie
proporzioni che coinvolgesse non solo il re e la sua famiglia ma anche il Parlameno, nei suoi due rami; questa idea era emersa da un
colloquio tra due cattolici che poi erano divenuti i due principali
organizzatori, come risulta dal racconto che segue (di �David Hume).
Nella
primavera del 1604, Catesby, gentiluomo di antica
famiglia, dotato di buone qualit�, aveva immaginato per vendetta, un modo pi� straordinario che mai, e ne
aveva parlato con Piercy, discendente dall�illustre
casato dei Northamberand.
Ragionando
un giorno tra loro dell�infelice condizione dei cattolici, mentre Piercy rieneva che il problema si
potesse risolvere assassinando il re; Catesby coglieva
l�occasione per fare un disegno pi� vasto, �che non solo avrebbe offerto una pi� sicura
vendetta, ma dava delle speranze, per restituire il cattolicesimo
all'Inghilterra, esprimendosi nel modo seguente: �Invano si toglierebbe la vita al re, se rimangono superstiti i suoi
figli che ascenderebbero al trono con le stesse massime di governo. Invano si �spegnerebbe la intera regia stirpe, perch�
nobili, gentiluomini e parlamento, infetti tutti da una stessa eresia,
innalzerebbero al trono un altro principe e un'altra stirpe che oltre ad
aborrire la nostra religione sarebbero animati dalla brama di vendicare la
morte dei suoi predecessori. Ad ogni buon fine occorre distruggere ad un tempo
re e regia famiglia, lords e Comuni, per seppellire
sotto una sola rovina i nostri nemici. Per buona sorte si radunano tutti alla
prima sessione del Parlamento e abbiamo cos� l'opportunit� di una gloriosa e
utile vendetta. Non occorrono grandi�
preparativi; bastano pochi di noi per collocare le polveri sotto la sala
dove sogliono congregarsi e nell'istante dell'arringa del re alle due Camere,
darvi fuoco e sterminare quei giurati nemici di ogni piet� e religione.�� ... �e gli empii che vi si trovano rinchiusi ...
passeranno dalle fiamme di questo a quelle dell�altro mondo per soffrirvi
eternamente i tormenti dovuti alle loro colpe�. Piacque a Piercy il progetto di Catesby e
convennero di parlarne col capitano Fawkes, che si
trovava nelle Fiandre e mandarono a chiamare con Thomas Winter.
�
Nessuno
dei partecipanti, commentava Hume, si era posto il problema di qualche dubbio
morale su questa carneficina, in cui si sarebbero trovati anche dei cattolici,
ma Tesmond membro, e Garnet
superiore dell�Ordine dei Gesuiti, tolsero ogni dubbio dimostrando come i
vantaggi della religione esigessero che l�innocente potesse essere, in quella cicostanza, sacrificato col reo (secondo altri li
benedissero, assolvendoli). Non solo, ma Everard Digby, uno dei partecipanti condannato a morte, scrivendo
alla moglie dopo la condanna, in riferimento alla strage che doveva essere
compiuta, le diceva di non aver ritenuto
di commettere peccato.
L�anno
seguente (1605) quando era stata fissata l�apertura del Parlamento un pari
cattolico, lord Monteagle, figlio di lord Morley, riceveva una lettera anonima che diceva: �Vi consiglio, se tenete alla vita, di
trovare qualche scusa per rinviare la vostra presenza al Parlamento, perch� Dio
e gli uomini si dispongono a punire la perversit� del secolo. Questo consiglio
non � da disprezzare in quanto � per il vostro bene e non vi pu� causare alcun
danno: il danno sar� passato quando avrete bruciato questa lettera�.
Lord
Monteagle, port� la lettera a Robert Cecil, che and�
a mostrarla al re. Il Cosiglio reale ritenne non
darle importanza, solo il re ebbe subito l�intuito di una esplosione. Nella ispezione
eseguita nella notte che precedeva l�apertura del Parlamento, (5 novembre
1605), infatti, sotto la Camera Alta, furono trovati in un magazzino di
carbone, trentasei barili di polvere da sparo, ricoperti da fagotti e fascine
di legna, sotto la guardia di Fawkes, che se ne stava
in un cantone al buio e aveva tutto l�occorrente per dar fuoco alla miccia;
messo sotto tortura fece il nome dei complici, tutti cattolici, tra i quali Catesby e Piercy, Digby, Rookwood, Winte che finirono nelle mani del carnefice; altri furono
uccisi nella contea di Warwick, per la resistenza
opposta con le armi, compresi i due gesuiti che avevano assolto Catesby e Piercy. �
*)
Era il capitalismo che secondo Karl Marx� stava nascendo dal protestantesimo, come
sostenuto da Max Weber o secondo Werner Sombart, si stava rinnovando.
�(**) Da tener presente che il
regime primitivo della amministrazione della Chiesa, era fondato sul governo
dei capi spirituali (vescovi) assistiti dai pi� considerevoli tra i� suoi fedeli.
***)
Il titolo completo era: Tortura torti.
Triplici nodo triplex cuneus,
sive apologia pro juramento
fidelitatis adverso duo brevia pontificus Pauli V et epistolam
cardinalis Bellarmini ad G.
Blanckvellum archypresbiterum
nuper scriptam. Londini excutebat Robertus Burckerus, 1607 in 4�.
****)
Giacomo I Stuart, dieci anni dopo �Demonomania�
di Bodin (v. in Schede S.: L�inquisizione tra intolleranza religiosa ecc. P. II) e i testi di Scot, pubblicava
(1597) il trattato �Demonologia� con il
quale non solo non cambiava la linea di credenze di Bodin,
ma criticava Reginald Scot� il quale nel suo libro �Scoperte della stregoneria� (1584) si era mostrato assolutamente
contrario alla interpretazione diabolica; successivamente, dopo i processi che
avevano coinvolto adolescenti, cambi� orientamento e giunse a negare quanto
veniva attribuito a streghe e diavoli.
*****)
Tradotto in italiano con versione inglese da Luca Tenneriello.�
���������������������������������������
LA FINE
DELLA SFORTUNATA
DINASTIA
DEGLI STUART
|
G |
iacomo
I di Scozia e d�Inghilterra moriva di febbre terzana avuta dopo una partita di
caccia (1625), lasciando, il figlio secondogenito Carlo, essendo morto il primogenito
Enrico e una femmina, Elisabetta, andata in sposa all�Elettore Palatino.
Quando
Carlo I ((1600-1649), assumeva il potere, si era
trovato gi� insediato ad avere le redini del regno. George Villiers,
duca di Buckingham il quale come �favorito
di Giacomo I che gli aveva concesso il titolo, aveva distribuito tutte le
cariche di Corte tra suoi uomini e, favorito anche del nuovo re, aveva nelle
sue mani tutte le leve del potere; era stato descritto come uomo ben fatto, il
pi� galante, magnifico e fiero, con lo spirito francese e cuore inglese;
conosceva tutte le astuzie di Corte e le sdegnava: ignorava gli affari e ne era
l�arbitro; il suo coraggio brillava nel calore di un combattimento e nel
pericolo mostrava il suo sangue freddo; abiuato alla
compiacenza del re, detestava chi gli opponeva resistenza. Sar� assassinato (28
agosto 1528) da un ufficiale di nome Felton il quale
non si diede alla fuga e nel suo cappello era stato trovato un biglietto con
l�ultima rimostranza della Camera; Feltono si era
giustificato dell�assassinio del duca, dicendo semplicemente che il duca era
nemico del regno.
Il
giovane re, imbevuto dei principi dell�autorit� sovrana che si era sviluppata
nel continente, contro le aspettative del popolo che pretendeva di prender
parte agli affari e al governo del regno, sin dall�inizio del regno, si metteva
in rotta con �il Parlamento.
Il
Parlamento era formato dalla Camera dei Lords,
composta originariamente da centoventi membri e dalla Camera dei Comuni, con cinquecento
tredici deputati che Carlo ��aveva ridotto (1549) a 80 rappresentanti.
Quando
all�inizio del regno Carlo I aveva convocato le due Camere (18 Giugno 1625), si
era trovato di fronte alla presentazione di una massa di griefs (*) da parte della Camera
dei Comuni, che per il loro esame ne avrebbero bloccato l�attivit�, per cui decise
il suo scioglimento.
Essendosi
presentata una nuova necessit�, il re convocava �(1626) le due Camere, che sperava di trovare
pi� docili; ma questa volta la Camera dei Comuni, accusando Buckingham,
protetto dal re, era risoluta a rovesciarlo, ma egli respingeva tutte le accuse
presentate nei suoi confronti e il re le scioglieva nuovamente (15 Giugno 1626).
Le necessit� (la guerra con la Francia per la Rochelle)
richiedevano una nuova convocazione e il Parlamento era nuovamente
convocato� (17 Marzo 1628); nel discorso
pronunciato alla sua apertura il linguaggio del re era stato fiero e minaccioso,
ma i rappresentanti dei Comuni avevano intenzione di proclamare le loro libert�
e farle riconoscere e si era formato un gruppo con lord Strafford
(Wentworth), Benzil, Hollis Pym e altri che erano alla
testa della coalizione parlamentare.
La
Camera dei Comuni (8 Maggio 1628) dopo aver votato la �Petizione dei diritti�, era stata presentata al re che doveva
firmarla, ma il re non si decidava a farlo; la
reazione era stata violenta e Carlo e Buckingham si erano spaventati, ma il re
prendeva ancora tempo concedendo una proroga alle Camere fino al Gennaio 1629. Ma
nel frattempo (7 Giugno 1628) il re si presentava alla Camera dei Lords, dove erano riuniti anche i rappresentanti del Comuni,
dai quali veniva nuovamente presentata la petizione,
che finalmente era approvata con la formula �sia reso diritto come richiesto� (Guizot,
Histoire de la R�volution d�Angleterre, Paris, 1845).
La
petizione disponeva tra l�altro, che il
re non potesse imporre tasse senza il suo consenso, la guarentigia della
libert� individuale dei cittadini e l�abolizione delle corti marziali. ��
Alla
scadenzaa della proroga, concessa alla Camera, Carlo
volle vendicarsi per la concessione della petizione,
chiudendo il Parlamento (gennaio 1629) e governando senza pi� riaprirlo fino al
1640, abbandonandosi ad arbitri di ogni genere, facendo rivivere diritti
aboliti, esigendo contribuzioni fino allora ignorate e perseguitando
particolarmente i puritani (che derivavano il loro nome dall�aspirazione e dal desiderio
di purificare le idee che si avvicinavano a quelle calviniste).
La
lotta di Carlo (che era stata guerra contro gli inglesi ribelli e scozzesi, di
cui non parliamo), col Parlamento diveniva guerra civile (1645) anche per le ambiziose
mire di Oliviero Cromwell, che faceva parte della
Camera dei Comuni ed era luogotenente generale di Fairfax, nell�armata del
Parlamento, sostenuto da� Ireton, Skippon e Fleetwod, membri del Parlamento, che mantenevano i rapporti
con l�armata, riempita di uomini di loro fiducia.
Costoro
sostenevano che l�autorit� sovrana inizialmente risiedeva nel popolo che
l�aveva concessa al re, scelto dal popolo,�
per governarlo secondo le leggi; avendo il re abusato del contratto
primitivo, l�autorit� sovrana ritornava al popolo che ne era il detentore. Cos�
i parlamentari, come rappresentanti del popolo si ritenevano in diritto di
cambiare la primitiva forma di governo, avuto riguardo al contratto che il re
aveva violato (**).
Da
ci� consegu� che la Camera dei Comuni (ma promotore segreto del colpo di Stato
era Cromwell) predisponeva un atto che aboliva la
monarchia e dichiarava la Repubblica.
La
Camera inoltre, all�inizio del mese di marzo, provvedeva a nominare l�Alta
Corte di Giustizia presieduta da John Bradshaw, per
processare il re che il 4 Giugno era�
prelevato a Holmby dal reggimento di Fairfax,
per disposizione di Ireton e Cromwell
(di cui Ireton era genero) e trattenuto nel castello
di Windsor.
Il
re era stato messo sotto accusa in base ai principi enunciati: 1. Che il potere
sovrano risiedeva nel popolo; 2. I Comuni d�Inghilterra, riuniti in Parlamento
essendo stati scelti per rappresentare il popolo, avevano nelle loro mani
l�autorit� della Nazione; 3. Che i Comuni dichiaravano di essere Legge, con
forza di Legge e il popolo era obbligato a obbedire, anche senza il consenso
del re e dei signori.
Questi
principi in fondo, erano contrari alla Costituzione del Governo inglese e
conformi a una dichiarazione di indipendenza, la cui intenzione era di cambiare
la monarchia in repubblica. L�Alta Corte nel giudizio del re, osservava le
stesse regole applicate a un criminale ordinario e il principale punto d�accusa
era che il re aveva fatto guerra al Parlamento e aveva voluto cambiare le
modalit� di governo, rendedolo arbitrariamente
tirannico.
Il
re aveva presentato una memoria in cui contestava la giurisdizione della Corte,
facendolo comparire come un delinquente; egli inoltre sosteneva che non poteva
essere giudicato senza l�autorit� delle leggi�
divine o municipali e che la Camera dei Comuni non aveva il potere di
nominare l�Alta Corte in quanto, per avere tale autorit� sarebbe stata
necessaria l�approvazione della Camera dei Lords e la
firma del re (cit. Guizot).
Il
re, condotto per tre volte davanti all�Alta Corte si era rifiutato di
riconoscere la sua giurisdizione e il rifiuto era stato considerato come
confessione. Teminato il processo con la sentenza, il
re era dichiarato colpevole di tradimento e condannato a morte e decapitato (***)
sul patibolo, fatto in prossimit� delle finestre della gran sala di Withe Hall.
Egli
aveva affrontato la morte con dignit� e poich� la causa della sua morte era
stata �anche la religione, era morto come
martire, come la nonna Maria (e anche
i rispettivi processi avevano delle somiglianze nelle arbitrariet�): fu sepolto
a Windsor nella cappella di Saint-Georges dov�era
sepolto Enrico VIII.
Alla
morte di Carlo I, dopo essere stato nominato un Consiglio di Stato, incaricato
del potere esecutivo, le redini del regno erano assunte da Oliviero Cromwell che instaurando il periodo della Repubblica democratica (1649-1659), attuava una politica di espansione che
assicurava all�Inghilterra la �Giamaica in
America e Dunquerke sulla Manica, sebbene di Cromwell sia stato detto che era stato pi� degno di esecrazione che di ammirazione.
Di
contro nei confronti della potenza commerciale olandese, con l�Atto di navigazione, col quale gli
stranieri potevano trasportare nella Gran Bretagna e in Irlanda i propri
prodotti; col divieto di cabotaggio, sicch� la marina
olandese che trasportava soprattutto prodotti altrui, fu come bandita dai porti;
questo atto spinse gli Inglesi ad armare numerose navi proprie e a gareggiare
con l�Olanda.
La
fattiva politica di Cromwell venne annullata dalla
restaurazione degli Stuart; Carlo II perseguiva una
politica d�intesa con
Carlo
II aveva sciolto la Camera dei Comuni, �governando senza di essa, quando questa, pretese
di escludere, suo fratello Giacomo
dalla successione perch� era cattolico e non avrebbe
potuto giurare �il �Test Act�; fu in quest�occasione che tra episcopali regi e presbiteriani repubblicani,
che si odiavano pi� dei protestanti e cattolici, si formarono i due partiti, distinti
in Tories e
Whighs; i primi riconoscevano la successione di Giacomo II, i secondi non la riconoscevano; questa divisione era
stata accompagnata da un enorme spargimento di sangue e una folla di crimini
(per l�odio che nasce tra gli antagonisti nelle religioni, come nei partiti come
succede ancora oggid�,�� ndr.).�
Cos�
Giacomo II pot� ugualmente
succedere al fratello nel 1688, ma si perse con �i suoi tentativi di stabilire il cattolicesimo
e dovette poi fuggire e abbandonare il trono di fronte a Guglielmo d�Orange, il
quale non esit� a giurare il Bill of rigthts, ossia
la costituzione che il popolo, rappresentato dal Parlamento, �aveva rispetto al re; questa lotta, iniziata
con Carlo I dal 1640 e cos� terminata, prendeva il nome di Gloriosa Rivoluzione.
L�Inghilterra
era cos� divenuta uno stato perfettamente costituzionale, quando il resto
dell�Europa era ancora in pieno assolutismo.
La dinastia portava in s� il gene della
sfortuna; non erano stati �stati solo Maria e Carlo I a perdere la testa sul patibolo;� erano stati preceduti sin dai primi �esponenti della dinastia come Giacomo I (1394-1437), figlio di Roberto III
Stuart, il quale mandato diciannovenne in Francia, era stato catturato da
Enrico IV d�Inghilterra e imprigionato nella Torre di
Londra. Con Enrico V� fu portato come �ospite� e trattenuto nel castello di
Windsor dove ebbe modo di scrivere un poema �Kingis Quair� considerato uno dei pi� notevoli
documenti poetici della letteratura inglese dopo Chuaucer.
Soltanto nel 1424 Giacomo potette tornare in
Scozia dove dovette affrontare la lotta contro i nobili ribelli dai quali venne
assassinato. Fu ucciso (1437) da sir Robert Graham, su istigazione del conte di
Atholl, ambedue giustiziati.
Giacomo II nato nel
1430 era stato incoronato all�et� di sette anni alla morte del padre
(1437);� morir� all�et� di trent�anni,
prendendo parte alla lotta tra le due Rose e rimanendo ucciso dalla esplosione
di un cannone nel 1460.
Gacomo III� nato nel 1451 era stato anch�egli incoronato da
bambino, all�et� di nove anni alla morte del padre (1460). Dopo aver fatto
arrestare due suoi fratelli che tramavano contro di lui, di questi, Giovanni
mor� in carcere in circostanze misteriose; l�altro fratello Alessandro, riusc�
ad evadere recandosi� presso il re di
Francia e poi in Inghilterra, dove era�
riconosciuto legittimo re di Scozia.
Giacomo III
dichiarava guerra a Edoardo IV (1482) ma fu battuto
e� ritornando in Scozia dovette
combattere contro i nobili ribelli, dai quali fu assassinato (1513). Giacomo V
padre di Maria e Giacomo VI (poi I di Scozia e
Inghilterra) nato un anno prima della morte del padre (1512) visse in mezzo
alle lotte fratricide dei nobili scozzesi, tra partigiani dell�Inghilterra e
partigiani della Francia, alle quali seguirono le lotte religiose tra
protestanti e cattolici.
*)
I Griefs
erano dei ricorsi che sospendevano l�attivit� per la quale erano� presentati ed erano di tre specie; 1. Contro
i privilegi del Parlamento; 2. In pregiudizio della religione;� 3. Contro le libert� del popolo. Nel primo
caso i membri del Parlamento non potevano essere imprigionati; essi erano;� la lbert� di
parlare liberamente; il potere di fare le leggi, di giudicare, dare consigli. Erano legati al Corpo politico come le
facolt� dell�anima sono legate al corpo dell�Uuomo.
Nel secondo, consisteva nell�incoraggiamento dato ai papisti (cattolici) e alla
loro religione. Il terzo, comprendeva diverse attivit� previste nel libro delle
Tasse, imposte dalle sole prerogative reali, tra le quali, il pagamento sul
tonnellaggio delle merci che era pari a uno scellino per lira sterlina di tutte
le mercanzie; altre come i Monopoli,
di cui vi era una inondazione di quelli dannosi 1. perch� producevano la
diminuzione della qualit� delle merci, del sale, del sapone, del carbone, della
birra ecc. e facevano alzare il loro prezzo 2. Sotto questo pretesto il
commercio era messo nelle mani di poche persone. 3. Tra costoro molti erano
imprigionati.
Il
Grief pi� importante era quello della Tassa dello Ship-Money che
significava danaro dei vascelli o per i vascelli; era una tassa imposta sui
porti, le citt� ecc.,� per servire alla
costruzione dei vascelli che Carlo I aveva rinnovato di propria autorit�.
**)
Gi� ricorrevano i principi poi espressi nel�
�Contratto sociale� �nel 1762
di Jean Jaques Rousseau.
***)
Il 30 Gennaio 1649, giorno in cui era celebrata la morte del re, corrispondeva
al 9 febbraio, in quanto l�Inghilterra non aveva ancora adottato il calendario
gregoriano.
FINE